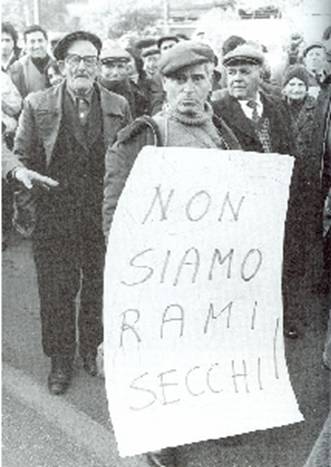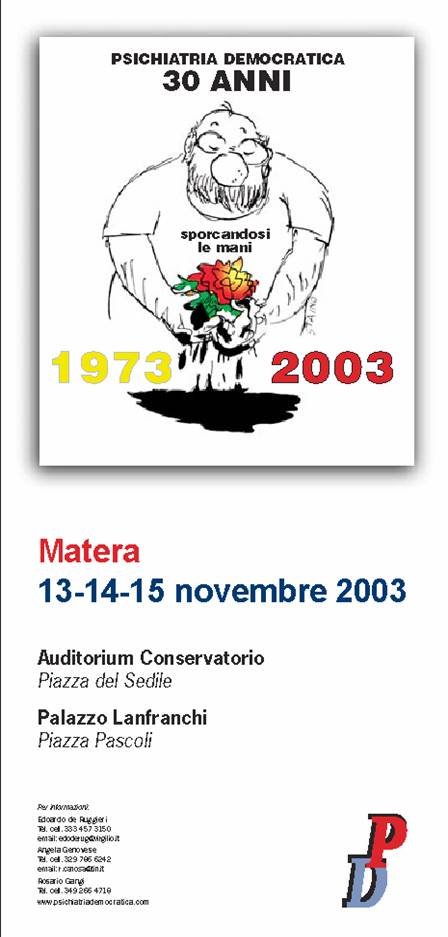Il mondo di oggi
può essere
descritto agli
uomini d’oggi
solo a patto che lo
si descriva
come un mondo che può essere cambiato
( B. Brecht).
INDICE
Introduzione
1
RIFERIMENTI STORICI
- La condizione
italiana pre-legem 180.
- Nascita e
intenzioni di un nuovo movimento.
- Il senso della
politica per P.D.
- La continuità di
intenti nel tempo.
- Gli strumenti
critici di P.D.
2
I problemi “aperti” di
psichiatria democratica.
- Dissoluzione della
psichiatria.
- Il dominio della
psicofarmacologia.
3
NUOVE LOTTE, VECCHIE
QUESTIONI
- Dare to care: un nuovo modo di “prendersi cura”.
- Unità alle
esperienze di riabilitazione, prevenzione e cura.
- Metilfenidato e
antidepressivi.
- Un buon servizio di
salute mentale.
Conclusioni
Allegati
Bibliografia
Introduzione
Psichiatria Democratica (P.D.) nasce in risposta alla
crisi del paradigma manicomiale dell’internamento psichiatrico che la
psichiatria istituzionale aveva fornito per affrontare la tematica della
malattia mentale. In questo senso, quindi, Psichiatria Democratica si può
definire come un movimento antipsichiatrico.
L’antipsichiatria, infatti, fu una corrente di
pensiero sorta all’interno della psichiatria e delle psicoanalisi europee e
nordamericane negli anni Sessanta e si impose sul panorama mondiale come
critica radicale del concetto di malattia mentale e delle forme, allora
correnti, di trattamento del malato (manicomi, terapie farmacologiche,
normalizzazione della devianza). Pur senza negare l’esistenza di stati di
disagio e di sofferenza psicologica, sostenne che nella grande maggioranza di
casi si trattasse non di malattie
organiche, disfunzioni o disturbi, ma di
condizionamenti psicologici ed ambientali, o il frutto di contraddizioni
sociali. L’antipsichiatria, quindi, si è definita attraverso una doppia
negazione, la negazione dell’Istituzione, e la negazione dei suoi concetti
fondamentali. Le differenti impostazioni antipsichiatriche possono schematicamente
essere ricondotte a quattro esponenti principali: R.D. Laing e D. Cooper in
Gran Bretagna, F. Guattari in Francia, T. Szasz negli Stati Uniti e F. Basaglia
in Italia (Universale, 2003).
1
RIFERIMENTI STORICI
1. La condizione italiana pre-legem 180.
Non si può parlare di antipsichiatria senza prima
trattare il contesto socioculturale che l’ha preceduta perché, in un certo
senso, è proprio in quest’humus culturale che essa trova la forza
e gli stimoli per manifestare attivamente i propri principi.
L’antipsichiatria, infatti, nasce in risposta a ciò
che Liberman (1997) definisce come “tematica della riabilitazione”, in
risposta, cioè, ai problemi della cronicità, della difficoltà della
deistituzionalizzazione, della nascita dei servizi territoriali (il cui
obiettivo era l reinserimento del paziente in un circuito di vita normale, di
comunità), dei “nuovi cronici” della revolving
door system, dei modelli psichiatrici multifattoriali. Le prime critiche
all’impostazione strettamente organicistica della psichiatria ufficiale e
soprattutto all’arretratezza delle strutture assistenziali hanno luogo a
partire dagli inizi degli Anni Sessanta, ma è con le lotte del Sessantotto e
del Sessantanove che queste critiche assumono un deciso carattere di
contestazione (Di Vittorio & Genchi, 2003). Le tematiche
dell’antiautoritarismo, del rifiuto del mito della scienza neutrale, della
denuncia delle istituzioni repressive (tematiche che resteranno negli
interventi di P.D.) trovano, in questo periodo, un riferimento pratico nel
campo psichiatrico italiano, grazie ad alcune esperienze già in atto, tra cui
quelle di Gorizia (1961) e di Trieste (1971) sono le più esemplari.
Non è privo di significato, quindi, il fatto che P.D.
sia nata in un contesto che coincide, da una parte, con il movimento di maggior
incisività della lotta contro l’ideologia psichiatrica e contro la sua pratica
repressiva, e, dall’altra, con il momento sociopolitico di maggior apertura di
tutti i movimenti che mettevano in discussione l’assetto sociale italiano
(basti pensare alla prova di forza del movimento operaio del Sessantanove o al
movimento studentesco dal Sessantotto in poi). Allo stesso modo, poi, si può
sostenere che la successiva repressione o il tentativo di razionalizzazione di
questi fermenti hanno coinciso con le fasi alterne del quadro politico generale
italiano (ibidem).
Intorno al 1973, quindi, sul territorio italiano si
registra una vasta serie di iniziative psichiatriche in vari settori, quasi
sempre separate l’una dall’altra (per una panoramica più dettagliata sui nuovi
servizi di salute mentale post-legem
180 si rimanda all’allegato A). E’
anche per dare loro unità e quindi maggior forza che nasce Psichiatria
Democratica.
A ragione, quindi, si può sostenere che il movimento
di P.D. si inserisca negli esempi di lotta antistituzionale nella misura in cui
esso
1) ricerca possibilità concrete di confronto tra
motivazioni e progetti degli operatori tecnici e degli utenti, a differenza
degli intenti pre-riforma basagliana;
2) pone come fondamentale il punto di vista
dell’utente (mentre prima, invece, era escluso dalla comunicazione sociale);
3) si fonda su un’esperienza collettiva che parte
dall’analisi dei livelli di potere in gioco e della loro distribuzione nel
campo sociale.
Una delle iniziali risposte , quindi, che tale
movimento dà al problema della salute mentale, come emerge dalle intenzioni del
suo documento programmatico, è riassumibile in
-Individuazione e lotta contro il proprio ruolo nei
confronti dell’utente del Servizio;
-Individuazione nella persona di bisogni sociali non
soddisfatti,che l’internamento cancella,
occultandosi sotto la diagnosi di malattia;
-Individuazione degli strumenti terapeutici impliciti
nel loro ruolo specifico,una volta liberato della strumentazione che il sistema
sociale attua attraverso la delega del controllo e del potere;
-Individuazione e riconoscimento delle persone e
delle forze sociali coinvolte e da coinvolgere in questa lotta (cfr. Allegato B).
In
altre parole, quindi, il gruppo di P.D. si propone la lotta all’esclusione ed
alla perpetuazione di meccanismi istituzionali separati e separanti anche nelle
strutture psichiatriche extramanicomiali.
2. Nascita ed intenzioni di un nuovo movimento.
Bologna, Ottobre 1973: nasce Psichiatria Democratica
per iniziativa di un gruppo di psichiatri raccolti intorno a Franco Basaglia
che, sull’onda dell’esperienza di Gorizia, si pone come obiettivo principale
l’abolizione del manicomio.
Esso, in altre parole, nasce n un contesto di
denuncia in cui l’assistenza psichiatrica, uscendo dall’ambito strettamente
specialistico, diventa un problema di rilevanza politica e sociale ed è su
questa base che, nel 1973, il movimento di P.D. enuncia le sue linee
programmatiche (cfr. Allegato B):
-
rifiuto
dell’istituzione come organizzazione di custodia e di controllo;
-
lotta contro
l’univocità di risposte all’internamento manicomiale e a quello carcerario;
In altre parole, la lotta contro l’internamento trova
la sua legittimità in quanto considera tale pratica incostituzionale; essa deve
inoltre avvenire attraverso “una riappropriazione della funzione terapeutica
specifica di organismi sanitari che non hanno mai svolto un ruolo terapeutico
nei confronti della malattia mentale” (Documento Programmatico, 1973) e
attraverso una depsichiatrizzazione di questi servizi.
In questo senso P.D. promuove e porta avanti una
denuncia contro il carattere repressivo delle istituzioni, iniziando a
considerare idee come migliori condizioni
di vita, difesa della salute ,
gestione sociale della medicina, crisi dei ruoli ed emarginazione non più, solamente, come obiettivi terapeutici, ma
anche come obiettivi politici.
3. Il senso della politica per P.D.
“Non si può fare psichiatria senza politica” (comunicazione
personale con Agostino Pirella, 2001).
A partire dall’esperienza basagliana, molti
amministratori e politici italiani appoggiarono P.D. perché compresero il
valore delle innovazioni della riforma: con il tempo, questo atteggiamento
venne frainteso dall’opposizione per sostenere la teoria secondo la quale
Psichiatria Democratica si era servita delle sue conoscenze politiche per
raggiungere i propri scopi: niente di più falso.
Il movimento politico, in altre parole, accompagnò e
sostenne le lotte del movimento (già a partire dai servizi territoriali e le
risposte alla crisi sul territorio) perché comprese la portata
dell’innovazione: non un semplice mutamento del modello psichiatrico, bensì empowering ecologico dei rapporti tra
istituzione e utenza, tra i malati e il loro contesto, per costruire una nuova
professionalità a contatto con i pazienti, con i familiari, con le realtà
sociali. Offrire risposte down-top al
disagio, risposte cioè che partano dalle richieste degli utenti e che siano
appoggiate da una visione meno statica della psichiatria, da un “prendersi
cura” che non debba , forzatamente, attendere l’approvazione burocratica delle
prescrizioni legislative: da ciò scaturisce la dimensione “politica”, e non
dalle relazioni con i politici.
4. La continuità di intenti nel tempo
“Compito dell'operatore psichiatrico è, dunque riportare
alla propria specificità un'istituzione e un rapporto che - sotto l'alibi di
codificazioni scientifiche diverse - prevedono invece solo la genericità del
controllo. Questo compito si attua attraverso la riappropriazione della
funzione terapeutica specifica di organismi sanitari che non hanno mai svolto
un ruolo terapeutico nei confronti della malattia mentale; e, al tempo stesso,
attraverso una "depsichiatrizzazione" di questi servizi, rendendo
esplicito il processo repressivo e discriminante che essi attuano e che con la
malattia non ha niente a che fare” (cfr. Allegato B).
Questo è l’incipit del documento programmatico di P.D. ed è proprio in questo
paragrafo, datato otto ottobre 1973 (anno in cui la legge 180 era ancora
lontana anche se l’imbroglio psichiatrico istituzionale era già stato
“smascherato”), che si ritrovano i due poli tra i quali oscillerà, come
sostiene Canosa (2000), tutta la pratica del movimento istituzionale italiano:
da una parte la valorizzazione dello
specifico terapeutico, nel senso di “prendersi cura di” e, dall’altra, l’uscita
dal sistema “psichiatria” ritenuto repressivo e inadeguato, se usato da solo,
in risposta alla complessità della sofferenza.
L’entrata in vigore della nuova legge del
1978 ha alimentato la lotta contro l’ospedale psichiatrico e ha segnato
l’inizio, da parte di P.D., di un faticoso lavoro di ricostruzione dei nuovi
servizi: in questa fase, che coincide con gli Anni Ottanta, i servizi che si
sono distinti nelle pratiche di deistituzionalizzazione assumono , sempre di
più, l’aspetto di “roccaforti” da difendere dai tentativi di revisione della
180, attuati dalle lobbies
pro-manicomio.
E’, dunque, questo il momento in cui si
inizia a scorgere la “presa in carico multidisciplinare” a cui Psichiatria
Democratica faceva riferimento nel suo documento programmatico: in questa fase,
infatti, operatori ed utenti si incontrano, si scontrano, possono progettare
insieme; i servizi psichiatrici diventano “Servizi di Salute Mentale”, in cui
l’enfasi è posta sulla normalità e sulla valorizzazione delle risorse personali
e di gruppo.
La “presa in carico”, però che in questi anni è giocata
prevalentemente all’interno dei servizi
psichiatrici, negli Anni Novanta diventa la principale metodologia per attivare
collegamenti, reti di supporto, interventi nel sociale allargato: ciò ha
consentito l’affacciarsi sullo scenario di nuovi soggetti portatori di diritti,
i familiari, gli utenti, le persone marginali . Tuttavia, tale processo, come
afferma sempre Canosa (2000), non è stato automatico, ma è stato la diretta
conseguenza dell’attribuzione di senso, da parte dei servizi, al disagio come
espressione di bisogni e desideri di persone reali, per trasformarli, alfine,
in soggetti propriamente detti.
Nel 1994, dopo una serie di proposte di
revisione della legge 180 ( che non sono state accolte grazie all’impegno di
Psichiatria Democratica e alle forze progressiste del Paese) viene approvato il
primo Progetto Obiettivo “Tutela Salute Mentale” che istituisce, in Italia, il
Dipartimento di Salute Mentale, definendone strutture, funzioni ed attività.
Negli anni successivi, insieme alla lotta per le risorse dei servizi, si
rafforza la convinzione che i servizi non possano produrre salute mentale da
soli, sia perché non hanno risorse sufficienti, sia perché il benessere
psicologico non è qualcosa che riguarda solo i tecnici “psy”, ma è anche il
risultato delle capacità di un’intera comunità di tollerare, sostenere, fare
emancipare le persone in difficoltà; per questo, i servizi più impegnati
incominciano a sviluppare una salute mentale di comunità, incarnando
l’obiettivo più politico di P.D., e cioè quello di calarsi nella realtà delle
persone che soffrono, senza risparmiarsi, “sporcandosi le mani” (espressione
utilizzata come titolo per la Conferenza di Matera, 2003; cfr. Allegato C).
Attualmente P.D. è interessata ad un
cambiamento trasversale, attraverso la scoperta di facilitatori di
processi, ad una pratica che vede
Psichiatria Democratica più attenta all’empowerment
che all’applicazione di modelli
predefiniti. Tale obiettivo, tuttavia, è raggiungibile solo in quei servizi che
hanno aperto spazi di negoziazione tra istanze contraddittorie e di confronto
tra saperi diversi, avendo sempre chiaro, però, l’obiettivo più generale della
lotta all’esclusione sociale.
Infatti, se cinquant’anni fa Psichiatria
Democratica ha lavorato dentro e contro il manicomio, per superarlo, oggi si
trova a lottare per la dissoluzione della psichiatria, intesa come apparato di strutture
specifiche e tecnici specializzati; in questo senso, quindi, dissoluzione della
psichiatria significa, in altre parole, difesa della diversità.
5. Gli strumenti critici di P.D.
Gli strumenti critici che Psichiatria
Democratica ha offerto per la difesa della diversità prendono spunto dalle
esperienze basagliane di Gorizia e di Trieste, dalla legge 180, per arrivare,
fino ai giorni attuali, sono strumenti che hanno conservato una coerenza
intrinseca e un’attualità tali da poter essere utilizzati come base di appoggio
per risolvere questioni ancora aperte.
Essi sono riassumibili, come è sostenuto
nel Manifesto per la Salute Mentale
del 2000 (cfr. Allegato D) e come sostengono
Di Vittorio e Genchi (2003), in
1) Soggettività
P.D., guidata da Franco Basaglia, ha
posto la questione dei diritti dei malati di mente ed ha affermato la necessità
di abolire i manicomi. P.D. è stato uno di quei movimenti locali che, nel corso
degli Anni Sessanta e Settanta, ha spostato l’attenzione pubblica dal pericolo
sociale alla soggettività della persona: esso è stato un movimento di
contestazione della “norma”, dove per norma si intende la naturalizzazione
arbitraria di un modello sociale (che poi va a legittimare, in altri termini,
la negazione giuridica dei diritti per coloro ai quali questo modello non si
adatta);
2) Etica
Il movimento di P.D. ha una valenza etica
non solo perché sottolinea l’irriducibilità di ciò che è soggettivo, ma anche
perché rifiuta l’idea che il potere sia qualcosa che sta al di fuori e contro i
soggetto agenti e che, quindi, per essere liberi, sia sufficiente liberarsi
della repressione e del dominio; in realtà, l’eticità di P.D. risiede proprio
nel cercare di offrire risposte concrete alle persone, senza occultare la
funzione normalizzatrice implicita nel ruolo tecnico dello psichiatra, per
poter quindi, alfine, rendere il rapporto terapeutico aperto allo scambio, al
confronto, alla negoziazione, al conflitto (ibidem);
3) Politica
Come sottolineato in precedenza, Politica, per Psichiatria
Democratica, significa, da una parte, vivere le contraddizioni istituzionali
per costruire insieme ai pazienti, alle famiglie, alla comunità, reali percorsi
riformistici, di emancipazione e di autodeterminazione, di lotta contro lo
stigma e l’esclusione, di riconoscimento e tutela dei diritti delle persone.
Dall’altra parte, essa va a si fa portavoce di una critica nei confronti di
tutti i progetti di riformismo politico volti a neutralizzare i conflitti sociali attraverso il pretesto
della modernizzazione (cfr. con l’attuale proposta di legge Burani-Procaccini e con i vari tentativi
di neoistituzionalizzazione).
In conclusione:
“
Quando diciamo diritti dei pazienti non ci riferiamo soltanto a diritti formali
che rimangono sul piano dell’etica e della politica, ma valorizziamo le
esperienze di cura e di riabilitazione che hanno ridato a migliaia di persone
la possibilità di vivere una vita da cittadino, con una propria casa, un
proprio lavoro e una propria pensione” (Pirella, comunicazione personale, 2005).
2
I problemi “aperti” di
psichiatria democratica.
La soggettività, l’eticità e la politica sono
premesse valide e strumenti utili al cambiamento, ma attualmente P.D., per
conferire legittimità politica (=pratica) ai principi che ha esposto nel suo
Manifesto (2000) e cioè agli ideali di Comunità, Opportunità, Responsabilità ed
Eticità (cfr. allegato D) ha dovuto,
e deve tuttora, legare strettamente insieme due livelli d’azione, tali da
poterla rendere realmente trasformatrice: il primo livello, specifico della
psichiatria, è rappresentato dalla continua e costante azione di lotta delle
istituzioni totali, alle concrete situazioni di neoistituzionalizzazione, alle
nuove forme di esclusione che il contesto storico-politico attuale produce. Il
secondo livello d’azione è rappresentato dall’interfaccia tra il servizio di
salute mentale e la comunità: esso si ritrova, come sostiene Canosa (2000), in
tutti quei luoghi, al confine con i servizio, in cui vanno emergendo nuovi
soggetti (familiari, adolescenti in difficoltà, immigrati, anziani soli, donne
ridotte in schiavitù, etc.) spesso esclusi dalla comunità. Tale interfaccia di
connessione è realizzabile attraverso un lavoro
di rete in cui la presenza di reti naturali ed informali, del volontariato,
delle associazioni, delle cooperative sociali, dei gruppi di utenti e
familiari, dei gruppi di self-help, è
sempre più evidente.
Queste nuove culture dei bisogni e dei diritti
ampliano il repertorio sinora utilizzato dei possibili modi di porsi sulla
scena sociale. Se da una parte l’innovazione favorisce il progresso,
dall’altra, però, può creare difficoltà nella gestione iniziale di una nuova condizio operanti.
Gli operatori dei servizi psichiatrici, infatti,
trovandosi, negli ultimi anni, di fronte ad una grande pluralità ed
articolazione di ambiti operanti, talvolta, mostrano la difficoltà di andare
oltre i limiti fisici e culturali del proprio servizio. L’altro limite attuale
che si può riscontrare consiste nella scarsa capacità di misurarsi con le situazioni
di “confine” del servizio,rimandandole ad un “dove” indefinito o delegandone ad
un mitico “volontariato” (ibidem).
Il lavoro che Psichiatria Democratica concretamente
fa, allora, grazie anche alle figure di Amministratore di Sostegno e di
Magistratura Democratica) è un lavoro finalizzato a favorire connessioni tra i
vari soggetti concretamente coinvolti nell’aiuto di una singola persona o ad
una categoria di persone con problemi.
In questo senso P.D.
ha mutato la sua veste negli anni, adattandola alle nuove esigenze e
alle continue trasformazioni della realtà: infatti, da portavoce di
problematiche legate solo alla salute mentale, si è fatta cassa di risonanza
d’esigenze e di conflitti in seno alla collettività.
1. Dissoluzione della psichiatria
Come emerge anche dagli Atti del Congresso Nazionale
di P.D. tenutosi a Vico Equense (2000), l’intento attuale del movimento (come
accennato nel paragrafo IV, cap. 1) è quello di lottare per la dissoluzione della psichiatria, nel senso di
- superare le nuove
istituzioni;
- uscire dal sistema
“psichiatria” e lottare contro ogni forma di esclusione;
- riconoscere
valorizzare e potenziare i soggetti portatori del problema;
- esplorare e
promuovere le reti naturali esistenti;
- attivare nuovi
soggetti disponibili a collocarsi nella rete;
- rendere accessibili
e fruibili i diritti degli utenti e delle loro famiglie.
Questo potrebbe essere, come sostiene Canosa (2000),
un possibile programma di P.D. nel ventunesimo secolo, e tale specifico
istituzionale va a collocarsi negli intenti “politici”, intenti, cioè,
orientati agli interessi della “polis” in senso etico e pratico: tali intenti,
infatti, possono diventare indicatori di una buona pratica solo se è possibile
valutare quanto siano stati in grado di trasformare la realtà (ibidem).
In questo senso, l’azione pratica del movimento si
trova attualmente di fronte all’arduo compito di superare l’ormai angusto
ambito professionale del sistema psichiatrico.
Essa, oltre ai valori appena esposti, si traduce, nel
contesto sanitario italiano, in un tentativo di
- superamento delle vecchie istituzioni (O.P.G:
Ospedale Psichiatrico Giudiziario, Carceri, Case di riposo, Istituti per
minori e per anziani, etc.);
- Impegno costante nel rendere accessibili e
fruibili i diritti di cittadinanza attraverso la lotta contro il
pregiudizio, lo stigma e la denuncia puntuale delle situazioni di
indifferenza e ingiustizia e di tutte le forme di discriminazione
etnico-religiose; la lotta contro lo stigma e il pregiudizio impone il
coinvolgimento e la collaborazione degli operatori dell'informazione a cui
si richiede la consapevolezza dell'importanza del loro ruolo anche in
questo campo e la scelta di operare per favorire percorsi di inclusione,
rinunciando alla facile criminalizzazione e drammatizzazione degli episodi
che coinvolgono il mondo della diversità;
- deistituzionalizzazione delle nuove
articolazioni istituzionali (S.P.D.C.:Servizio Psichiatrico per la
Diagnosi e la Cura, S.R.: Strutture Residenziali, etc.) e critica degli
atteggiamenti e degli stili di lavoro ancora presenti in taluni Servizi,
fondati sulla semplice attesa della domanda o sulla riproduzione di
attività operative mutuate dalla logica privatista, o, addirittura, di
forme di controllo e costrizione vecchie e nuove (C.N.P.D., 2000).
Su quest’ultimo punto, infatti, si può aggiungere che
i Dipartimenti di Salute Mentale rischiano oggi di diventare luoghi di
smistamento dell’utenza, senza alcun progetto terapeutico; esso è, quindi, il
terreno in cui collegare le prassi operative per contrastare la
neoistituzionalizzazione degli interventi e dei servizi, in un contesto di
politiche sanitarie attuali che medicalizza sempre più la sofferenza, e che, con
altrettanta frequenza, sostituisce il “curare” (to cure) al “prendersi
cura” (to take care): questo aggiunge
sullo scenario di intervento di Psichiatria Democratica
2. Il dominio della psicofarmacologia
La crisi del paradigma psichiatrico istituzionale,
come emerge dall’articolo di Pirella (2004), non solo aprì la strada ad una
psichiatria riabilitativa territoriale, ma, a partire dagli Anni Sessanta e
Settanta, portò ad un ridimensionamento del ruolo dello psicofarmaco, in favore
di altre “tecniche” di cura (tra cui la stessa psicoterapia individuale e di
gruppo) e di riabilitazione (come, ad es., l’accesso da parte dei pazienti alle
risorse disponibili quali la casa, il lavoro, la socialità).
2.1 Ripresa del paradigma
A distanza di alcuni anni, però, l’adesione acritica
e strumentale della psichiatria ai metodi delle neuroscienze ha riaffermato con
forza le teorie biologiche della malattia mentale e il modello terapeutico
farmacologico: questo è il motivo per cui i “nuovi” antidepressivi e
antipsicotici furono presentati non solo come efficaci, ma come risolutori
esclusivi ed assoluti.
Riprendendo ciò che anche Pirella riporta nel suo
articolo (ibidem), appare evidente il
legame tra guarigione “miracolosa” di nuovi neurolettici, Case farmaceutiche e
strategie di sviluppo del mercato che comportano il finanziamento di
ricercatori esterni alle Case produttrici, fino ai legami con le Università e
gli ambienti accademici.
Di seguito viene riportata una critica tratta dal New Journal of Medicine:
“C’è
ora una considerevole evidenza che i ricercatori con legami con le Case
farmaceutiche sono in realtà più adatti a riferire risultati favorevoli ai
prodotti di quelle aziende rispetto a ricercatori senza quei legami. Ciò non
prova conclusivamente che i ricercatori sono influenzati dai loro legami
finanziari con l’industria. Comprensibilmente le Case farmaceutiche scovano
(seek out) ricercatori che capita ottengano risultati positivi. Ma io ritengo
che la distorsione (bias) sia la spiegazione più adatta, e in entrambi i casi è
chiaro che più sono entusiasti i ricercatori e più è sicuro che essi siano finanziati
dall’industria. Molti ricercatori pretendono di essere oltraggiati dalla sola
idea che i loro legami finanziari con l’industria potrebbero influenzare il
loro lavoro. Essi insistono che, come scienziati, possono rimanere obiettivi,
non importa quanto siano blanditi. In breve, essi non possono essere comprati.
La questione non è – insiste l’autrice della denuncia – se i ricercatori
possono essere “comprati” nel senso di un “quid pro quo”. E’ che questa stretta
e remunerativa collaborazione con una azienda industriale naturalmente crea
benevolenza da parte dei ricercatori e la speranza che l’elargizione continui.
Questo atteggiamento può sottilmente influenzare il giudizio scientifico in
modi che possono essere difficili da identificare”. E qui l’autrice si pone una
domanda cruciale. “Possiamo noi realmente ritenere che i ricercatori clinici
siano più immuni verso i propri interessi delle altre persone?” (Angell, 2000).
Come ha denunciato anche Psichiatria Democratica in
numerosi articoli, questa è la dinamica psicologica e politica predominante e
ciò è altresì dimostrato dall’assoluta prevalenza di indicazioni farmacologiche
per tutta una serie di disturbi psichiatrici in cui l’esperienza dimostra
l’utilità e l’efficacia di metodiche diverse.
2.2 Efficacia o intrecci di interessi?
Una delle lotte che sta perseguendo P.D., e in un
certo senso, quindi, una delle molte risposte che il titolo di questa
dissertazione ha stimolato, è quella di smascherare la singolare contraddizione
tra lo stato di realtà delle ricerche sulla correlazione tra disturbi mentali e
presunta base biologica di essi e l’enfasi sulla necessità di trattamenti
farmacologici; come sostiene Pirella (ibidem),
infatti, la traduzione di questo messaggio fallace, in termini di diffusione culturale
nella popolazione, rappresenta il tentativo del completo dominio della
“non-santa alleanza” (unholy alleance,
Mosher, 1998; cfr. Allegato E) tra
le associazioni psichiatriche e l’industria farmaceutica: basti pensare, come
citazione esemplificativa, che il manuale diagnostico D.S.M. ha venduto 2,5
milioni di copie ed è stato tradotto in ventuno lingue, dettando norme di
inquadramento diagnostico coerenti con le prescrizioni farmacologiche
(confronto alquanto impari con il sistema nosografico dell’OMS/WHO, ovvero
l’I.C.D.) e che il trattamento considerato efficace è quello esclusivamente
erogato dal curante/esperto tramite prescrizione di psicofarmaci e/o di
“psicoterapia manualizzata” (dicesi
tale quella psicoterapia autorizzata e tecnicizzata), nonostante le esperienze
italiane di deistituzionalizzazione e quelle più specificamente riabilitative
abbiano dimostrato la loro efficacia anche fuori da questo paradigma duale.
Per esigenze di spazio non è possibile trattare in
modo più approfondito gli intrecci di interessi tra Case farmaceutiche,
psichiatri ed ambienti della ricerca ed accademici; si rimanda, tuttavia al
testo di Pirella (2000) per una trattazione generale sulla questione, ai testi
di Valenstein (1998) e Mosher (1998, Allegato E), per la discutibilità dei trattamenti a base di metilfenidato ai testi di Bregging
(1998), per l’uso di psicofarmaci sui bambini e il conseguente scandalo
“celato” della paroxetina (Seroxat)
della Glaxo Smithkline si rimanda a The Lancet (2004) e al Canadian
Medical Association Journal (2004).
Al di là della questione sull’utilità assoluta degli
psicofarmaci (la cui discussione non rientra nelle questioni specifiche di tale
dissertazione), mi sembra importante precisare come, facendo emergere in modo
dettagliato e puntuale (come risulta dall’articolo di Pirella) le principali
contraddizioni all’interno delle strategie di dominio del mercato
psicofarmacologico, Psichiatria Democratica si impegni a rispettare il suo
principio di Eticità (cfr. Allegato D), per impedire, ancora una volta, che
la logica del profitto strumentalizzi la sofferenza dei malati psichiatrici.
3
NUOVE LOTTE, VECCHIE
QUESTIONI
La storia di Psichiatria Democratica, i suoi dubbi e
le sue lotte, i suoi valori e la sua politicità, ci portano, infine, a
rispondere, in modo più o meno esaustivo, alla domanda “Cos’è rimasto, oggi, di
P.D.?”, anche se, in realtà, non è possibile formulare una risposta definitiva
ai problemi posti finora, in quanto le risoluzioni non possono essere altro che
risposte provvisorie, contestuali, mutabili, in una parola, in fieri. Tuttavia, è possibile e anche
auspicabile analizzare criticamente il significato e la portata della riforma
psichiatrica nel contesto italiano attuale e i modelli di risposta in tema di
salute mentale; in altre parole, ridefinire gli intenti di P.D. alla luce delle
nuove trasformazioni.
1. Dare to care:
un nuovo modo di “prendersi cura”.
Il titolo di questo paragrafo riprende lo slogan usato dall’Organizzazione
Mondiale della Salute Mentale per introdurre metaforicamente il presupposto che
Psichiatria Democratica afferma implicitamente .
Come sostenuto in precedenza, la tendenza dominante
nella psichiatria degli ultimi due secoli ha determinato l’internamento di
milioni di esseri umani nelle cosiddette “istituzioni della violenza”
(Basaglia, 1968) che sono entrate in crisi a causa di fattori tra loro molto
diversi: il crescente costo dei posti-letto,la maggiore sensibilità collettiva
nei confronti dei diritti dei pazienti, la consapevolezza del carattere nocivo
dell’internamento e, in modo contraddittorio, appunto, l’introduzione degli
psicofarmaci.
Di fatto, in Italia, le esperienze di trasformazione
degli Anni Sessanta e Settanta già citate hanno portato alla riforma ed alla
chiusura dei manicomi, ma anche ad un modo diverso di prendersi cura, più
centrato sui bisogni della vita quotidiana del paziente, sul rispetto del suo
punto di vista, con un legame sempre costante alle risorse sociali, alla
possibile uscita dallo spazio puramente psichiatrico. In questo senso,
imprendersi cura (take care) si pone in antagonismo alla cura
repressiva (cure), ad un trattamento
puramente medico di problemi che, in realtà, sono anche sociali ed economici;
mentre to cure mantiene la filiazione
dal paradigma storico dell’internamento, con un’attenzione esclusiva ai
sintomi, alla diagnosi, alla terapia
farmacologia e ad una riabilitazione separata dai contesti di vita, la seconda
modalità di interazione (to take care) realizza forme di supporto a partire
dalla crisi, tali da non separare l’interessato dal suo contesto e comunque in
modo da facilitare ruoli di protagonismo del paziente nella difesa della sua
salute. Il che significa, come sostiene Pirella (2001),
“occuparsi,
insieme alla persona che abbiamo davanti, dei problemi della vita quotidiana,
dell’abitare, del denaro, del mantenimento o ricerca di un lavoro, dei momenti
di socialità. Sono cioè individuati tutti i fattori che possono influire sul
destino della persona interessata ed affrontati insieme a lei, eventualmente
discussi, accantonati per il momento, rinviati, ma pur sempre tenuti presenti
secondo una logica di prevenzione dell’aggravamento o di risposta alla
“gravità” della situazione”.
2. Unità delle esperienze di prevenzione,
riabilitazione e cura.
Il nuovo modo di prendersi cura citato nel punto
precedente implica non solo un nuovo modo di fare sanità ( “Se si cura soltanto la malattia, si occultano bisogni materiali e
soggettivi e rapporti sociali, e si produce dipendenza, lungodegenza,
cronicità”, F. Ongaro Basaglia cit. in L’invenzione
collettiva, 1999), ma anche una nuova concezione di “malato”.
In Italia, infatti, la riforma si è concretizzata in
esperienze puntiformi: permangono isole di disapplicazione, di sofferenza anche
grave, di cattive pratiche, come ha denunciato il Forum per la salute mentale
nell'ottobre 2003 a Roma (Moretti, 2003).
“La
contraddizione tra questa diffusione, rappresentata da migliaia di luoghi di
socializzazione, di lavoro comune tra operatori, volontari, utenti, familiari,
amministratori, gente dei quartieri, nuovi poveri, patrocinatori, ricercatori,
cooperatori, giovani e ragazze, e la rocciosità delle case di cura
neuropsichiatriche, degli SPDC, delle nuove/vecchie strutture della psichiatria
routinaria e preformata, ci si presenta come la nuova sfida del secolo appena
iniziato, in termini del tutto nuovi rispetto al passato” (Pirella, 2003).
Mentre in alcune regioni italiane,infatti, le
richieste dei pazienti vengono ascoltate e sostenute in modo flessibile e
aperto, in altre, invece, la riforma psichiatrica ha utilizzato un modello che
prevede la netta divisione di compiti tra chi gestisce la crisi acuta
(S.P.D.C.) e chi, in modo spesso insufficiente, risponde sul territorio a tutti
i problemi dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo.
Tale frammentarietà è aggravata dal fatto che i
progetti riabilitativi siano spesso sostituiti da lungodegenze in strutture
cosiddette riabilitative ma che, in realtà, riproducono (in modo celato, grazie
alla modernità e all’accoglienza apparente che ostentano) le caratteristiche
dei vecchi ambienti manicomiali, nel senso che sono caratterizzate da mancanza
di libertà, divieti, dipendenza dagli operatori, assenza di progettualità per
il futuro: caratteristiche già denunciate da Goffman (1961) e Basaglia (1968)
come nocive per la salute mentale degli internati.
Psichiatria Democratica cerca appunto di manifestare
una presa in carico totale del paziente, affrontando con lui, ad esempio, la
questione del denaro, di un lavoro, dei momenti di socialità). Tale strumento è
la diretta testimonianza, da parte di P.D. e delle esperienze italiane che si
richiamano ad essa, di una precisa concezione di uomo, di basagliana memoria,
che porta a considerare tutte le variabili coinvolte senza mai, però,
sostituirsi alla libertà della persona: i pazienti, parafrasando una citazione
di Basaglia, devono essere trattati come uomini, uomini in “crisi” (dal greco,
krìno: scelta, giudizio, decisione, che richiama il concetto di separazione tra
un prima e un dopo terapeutico), certo: una crisi esistenziale, sociale,
familiare, che però non è più “malattia” o “diversità”.
Il prendersi cura, inoltre, dovrebbe servire a P.D.
per ribellarsi alle false risposte istituzionali che stanno alla base di
“contenitori”statici e ben poco riabilitanti: basti pensare ai preoccupanti
risultati che emergono da una ricerca piuttosto recente dell’Istituto Superiore
di Sanità: nel 1999, in Italia, dal 37% delle strutture non è stato dimesso
nessun paziente, dal 31,7% è stato dimesso 1-2 pazienti e solo dal 31% di esse
sono stati dimessi più di due pazienti (Pirella, 2003).
3.
Metilfenidato e antidepressivi:
il mercato psicofarmacologico invade l’infanzia.
Un’altra nuova lotta che riapre vecchie questioni è
quella che ruota intorno all’uso più o meno lecito di psicofarmaci, ma
attualmente con un’aggravante in più: il coinvolgimento di minori.
I risultati che l’O.M.S. ha fornito sulla diffusione
dei disturbi psichici (un bambino su cinque con disturbi) durante la giornata
mondiale della salute mentale, destano un sospetto lecito: da una parte,
infatti, tali risultati sembrano orientati ad incrementare il numero degli
specialisti, nonostante sia nota la natura storica (guerre, violenze,
condizione di profugo, etc.) e socio-economica (precarietà, abitazione
inadeguata, etc.) di molte minacce attuali, per i cui rimedi non stati
certamente coinvolti sufficienti specialisti. Dall’altra, però, la denuncia a
cui fanno appello recentemente i rappresentanti di P.D. (cfr. articoli da
L’Unità, 2003, 2004) riguarda, tuttavia, una minaccia forse più urgente; le
potenti lobbies delle multinazionali
del farmaco, infatti, per i motivi riportati nel paragrafo II del cap. 2,
esercitano forti pressioni sui poteri politici e sugli stessi specialisti circa
la necessità di identificare precocemente e trattare coi farmaci il maggior
numero possibile di persone, tra cui, e questo è lo scandalo, i bambini. Si
stima ce in USA, dal 1990 al 1995 il consumo di psicofarmaci nei bambini è
aumentato di sei volte per il metilfenidato (che si sta cercando di introdurre
anche in Italia) e sono ormai di prescrizione comune anche gli antidepressivi,
il cui consumo, per i bambini tra i sei e i dodici anni è aumentato, sempre
negli USA di tre volte dal 1995 (Pirella, 2004).
P.D. contesta con forza l’affermazione infondata
secondo cui un bambino su cinque presenta disturbi psichici e denuncia il
frutto scandaloso di questa campagna promozionale (Pirella, 2003). Tale
questione, infatti, non riguarda soltanto il problema etico, per altro
gravissimo, della difesa dell’infanzia
come valore assoluto, ma, promuovendo l’uso di farmaci i cui effetti a lungo
termine non sono ancora noti, riguarda anche il problema sociosanitario di
dimensioni catastrofiche che si andrebbe a creare: un “allevamento” di malati
da curare.
4. Un buon servizio di salute mentale.
L’impegno del movimento di Psichiatria Democratica è,
tuttavia, quello di non fossilizzarsi su un’unica risposta, ma è quello di
produrre continuamente cambiamenti nelle persone, ma anche negli operatori,
negli specialisti, per evitare che si cronicizzino anch’essi.
Come
ha sostenuto Emilio Lupo, segretario nazionale di P.D., durante un’intervista:
“Molti
Servizi funzionano male, non perché esistono pazienti cronici, ma perché
esistono operatori cronicizzati nella routine... di "nuova
cronicità". Non esiste una "nuova" o una "vecchia"
utenza. Esiste una utenza. E a questa utenza và data una risposta che non può
essere una risposta "pre-confezionata" come era quella, ieri, del
manicomio e quella odierna del territorio. .. Esistono persone che da sole non
ce la fanno e che bisogna sostenere ed aiutare a riprendere la loro vita tra le
mani” (http://www.pol-it.org/ital/180/lupo.htm).
Questo,
tuttavia, non significa negare l’esistenza della malattia mentale, ma neppure
sostenere che questa sia da considerarsi “inguaribile”; citando Basaglia
(1968), si può sostenere che la malattia
mentale esiste ma è tra “parentesi”: nella parentesi esiste l’uomo, la
singolarità di tutte le persone, persone che hanno dei diritti e la necessità
di declinare questi diritti.
Un buon
servizio di Salute Mentale, quindi, è un servizio che è mosso da una concezione
riabilitativa della malattia mentale, esso non
si misura dalle risorse o dagli spazi che possiede, ma da quale idea ha
dell’uomo (ibidem). E questo è il
motivo per cui è lecito dire, come sostengono Canosa e Lupo (2003), che Psichiatria Democratica affonda le
sue radici in quei no contenuti ne L’Istituzione Negata:
“Noi neghiamo dialetticamente il nostro mandato sociale che
ci richiederebbe di considerare il malato come un non-uomo e, negandolo,
neghiamo il malato come un non-uomo.
Noi neghiamo la disumanizzazione del malato come risultato
ultimo della malattia, imputandone il livello di distruzione alle violenze
dell’asilo, dell’istituto, delle sue mortificazioni e imposizioni; che ci
rimandano poi alla violenza, alla prevaricazione, alle mortificazioni su cui si
fonda il nostro sistema sociale.
Neghiamo tutto ciò che può dare una connotazione definitiva
al nostro operato. Nel momento in cui neghiamo il nostro mandato sociale, noi
neghiamo il malato come irrecuperabile….” (Basaglia, 1968).
Allora, un
buon servizio di Salute Mentale significa poter garantire l’assistenza
ventiquattro ore su ventiquattro, ascoltare una persona che ha bisogno di
essere ascoltata, accolta e curata; tuttavia, significa anche liberarsi degli
stereotipi della malattia mentale che sono rappresentati dall’incapacità,
dall’urgenza e dalla cronicità (Lupo, Intervista).
CONCLUSIONI
Per
rispondere alla domanda “Cos’è rimasto di Psichiatria Democratica oggi?” sono
state fornite numerose chiavi di lettura, testimonianze (cfr. Allegato F) che la realtà psichiatrica per
definirsi democratica non può e non deve fornire modelli prefabbricati di
risoluzione ed universali; deve piuttosto fornire risposte contestuali a
richieste specifiche. Non esiste, in altre parole, un paziente che è sempre
“cronico”: esiste una persona alla quale vanno date possibilità di riscatto
nella realtà stessa della sua esistenza e non in altri luoghi, in spazi di vita
in continua evoluzione, al cui interno ci sono “persone” e non “malati”.
In questo
senso Psichiatria Democratica può essere considerata come un movimento
estremamente attuale, proprio perché ha la capacità di mutare insieme alle
condizioni socio-politiche, ma senza per questo dimenticare i valori per cui è
stata istituita.
Per sottolineare
tale versatilità di pratiche, ma non di intenti, è riportata di seguito la
testimonianza del segretario nazionale
di Psichiatria Democratica, Emilio Lupo, il quale sembra rispondere, seppure
per via indiretta, alla questione che ha mosso tale dissertazione:
G.Esposito
- Prof. Lupo, cos'è
oggi Psichiatria Democratica? Quali sono i suoi programmi nel campo dell'assistenza
psichiatrica italiana?
E.
Lupo
- Qualche
tempo fa ho dichiarato in un'intervista che Psichiatria Democratica è un luogo
di elaborazione teorica, è un luogo di confronto sulle pratiche del nostro
Movimento su tutto il Rispetto ai progetti perseguiamo ancora la de-istituzionalizzazione.
Non pensiamo assolutamente che questa inizia e finisce con i manicomi. La
de-istituzionalizzazione è legata ad un processo continuo , bisogna sempre
rimettere in discussione tutto, per esempio il Centro Diurno può diventare
una istituzione totale, di conseguenza riteniamo che Psichiatria Democratica
sia un "luogo d'incontro di operatori che utilizzano la Psichiatria per
produrre la Salute Mentale". Quest'ultima non è promossa soltanto dagli
operatori della Salute Mentale, ma è un luogo che connette vari saperi e soprattutto
il sapere pratico, che è quello col quale vogliamo sviluppare in un continuum
la nostra teoria e la nostra pratica: 'Pratica della Teoria' e 'Teoria della
Pratica'.
Vorrei
concludere questa dissertazione su Psichiatria Democratica lasciando la parola
ai veri soggetti del cambiamento, ai veri soggetti di P.D.
Se fossi matto chiederei ...
di
Emilio Lupo
|
Se fossi matto mi interrogherei sul tempo. Nel
manicomio infatti il tempo non esiste. Se mi dicessero che siamo nel 1997, mi
interrogherei, ancora una volta, sulla vita e sul tempo che mi è stato
rubato, sulle cose che non ho potuto fare e su quelle che mi sono state
impedite.
Se fossi matto mi chiederei perché dopo tanto tempo
dalla legge di riforma psichiatrica sono ancora qui. Perché nonostante la
legge 180 di vent’anni fa e le leggi regionali sulla salute mentale che mi
facevano sperare di uscire da questo luogo dove mi hanno tolto i miei
indumenti, legato, imbottito di psicofarmaci, rasato i capelli, dove ho mangiato
cibo che altri sceglievano per me, dove mi hanno rubato il sonno, il sogno,
la speranza e la gioia di vivere, sottratto tutti i miei diritti e sopratutto
la libertà, non è successo assolutamente nulla di importante per me.
Se fossi matto vi chiederei perché oggi alcuni pensano
di lasciarmi ancora in manicomio, perché a due anni dal duemila sono oramai
più vecchio che matto e perciò i vecchi, che contano come i matti, è meglio
che non si muovano, non si debbono muovere da qui. E quelli che sono vecchi,
forse, potranno venir fuori.
Se
fossi matto vi chiederei: che state facendo per me?
Se fossi
matto vi chiederei com’è il mare, di che colore è il vostro cielo, qual’è il
profumo della vostra donna e se esiste ancora la casa dove sono nato.
Se fossi matto vi parlerei degli
elettroshock subiti negli anni addietro, dei terribili momenti dell'attesa
prima dell’applicazione degli elettrodi, delle urla, dell'intenso odore di
urine, della voce dell’infermiere che ti chiama per nome e del medico che questo
nome nemmeno conosce.
Se fossi matto vi parlerei dei lunghi inverni passati in
reparto, a contare le mattonelle, delle allucinazioni che mi hanno aiutato a
sopravvivere, dei cessi sempre sporchi e dei riscaldamenti sempre guasti.
|
Se fossi matto vi parlerei del caldo di agosto, dei
miraggi del mare che passavano per allucinazioni.
Se
fossi matto vi chiederei di vedere la Casa Famiglia del mio quartiere, di
conoscere gli operatori del mio Distretto, di guardarli negli occhi, di
parlare con loro del mio futuro, del mio presente.
Se fossi matto vi chiederei di mangiare la neve, di
andare al cinema, di sapere se posso chiamare di notte se dovessi sentirmi
male o semplicemente solo.
Se fossi matto vi chiederei quanti soldi valgono le
cure che mi date, di conoscere quanti denari si spendono nei manicomi e nelle
cliniche private.
Se fossi matto vi chiederei perché dopo tanti anni
rinchiuso qui non ho ancora la pensione, oggi che sono non solo matto ma
anche vecchio e voi non riuscite a tutelarmi né come anziano né come pazzo.
Se fossi matto vi chiederei di sapere perché spendete
tanti soldi per il privato accreditato e tanto poco per il pubblico
dimenticato. Il pubblico, difatti, mi rassomiglia.
Se
fossi matto vi chiederei che fine ha fatto il Progetto-Obiettivo «Tutela
della Salute Mentale» e perché i manicomi privati non fanno nemmeno finta di
chiudere.
Se fossi matto vi chiederei di stanare quelli che fanno
ancora l’elettroshock senza consenso e senza nessuno a cui dar conto della
sua efficacia.
Se fossi matto firmerei un appello contro le guerre, mi
appellerei ai poeti, agli anchormen, ai pittori, ai matematici, ai cantautori
e ai politici perché mi dicessero, ognuno a modo proprio, dei fetori del
manicomio, del prezzo della vita, dei rigidi inverni, delle mattonelle
contate mille volte, del suono dei pianti, delle leggi mai applicate e dei
volti dei matti ormai sfioriti.
Se fossi matto vi chiederei del mio
futuro, del mio presente. Vi chiederei di me.
|
Emilio Lupo, pubblicato su
"Repubblica" edizione Napoli del 29/11/97
ALLEGATO A:
STRUTTURA DEI SERVIZI
DI SALUTE MENTALE IN ITALIA
Un passo importante seguito alla riforma operata
in seguito alla legge 180 è stato il decentramento dei servizi, costituito da
strutture territoriali in cui si sono inseriti operatori in contatto più
stretto con la collettività, e in grado quindi di pianificare degli interventi
diretti ad una fascia di utenza più circoscritta. Questo tipo di innovazione ha
creato una scissione rispetto al passato, perché vede il disagio mentale
inserito in un contesto, in una realtà, all'interno della quale affrontare il
problema della sofferenza, nel rispetto della persona e del suo diritto a non
essere alienata dalla "propria realtà".
Brevemente verrà riassunta la
differenziata situazione italiana circa le strutture attuali che si occupano di
salute mentale.

Il D.S.M.:
si occupa dell’organizzazione, gestione e produzione delle prestazioni
finalizzate alla promozione della salute mentale, alla prevenzione, diagnosi,
cura e riabilitazione del disagio psichico, del disturbo mentale e delle
disabilità psicofisiche delle persone per l'intero arco della vita.
Esso comprende:
·
CENTRO
DI SALUTE MENTALE; il C.S.M. è la sede organizzativa degli operatori e
del coordinamento nel territorio di competenza degli interventi di prevenzione;
cura riabilitazione e reinserimento sociale. In particolare il Centro di Salute
Mentale svolge: attività di accoglienza, analisi della domanda ed attività
diagnostica, definizione ed attuazione di programmi terapeutico-riabilitativi e
socio-riabilitativi personalizzati, tramite interventi ambulatoriali,
domiciliari e di rete; consulenza specialistica ai servizi di confine, alle
strutture residenziali per anziani e per disabili e agli Ospedali collocati nel
territorio competente; attività di filtro ai ricoveri e di controllo della
degenza nelle Case di Cura Psichiatriche accreditate, al fine di assicurare la
continuità terapeutica.
·
SERVIZIO
PSICHIATRICO di DIAGNOSI e CURA:L’S.P.D.C. è il reparto ospedaliero dove
vengono attuati trattamenti psichiatrici volontari ed obbligatori (T.S.O.) in
condizioni di ricovero; è parte integrante del Dipartimento di Salute Mentale .
·
CENTRO
DIURNO : è una struttura semiresidenziale, collegata al Centro di Salute
Mentale (C.S.M.), con attività terapeutiche e riabilitative, con particolare
attenzione alla risocializzazione dell'utente, attraverso progetti
individualizzati. Ha il compito di prevenire e contenere il ricovero,
promuovere programmi riabilitativi e risocializzanti individuali ed integrati
per gruppi omogenei di utenti, di supportare gli inserimenti formativi,
lavorativi ed occupazionali con livelli differenziati di protezione.
·
COMUNITÀ
PSICHIATRICA: è una struttura residenziale con elevato livello di
attività terapeutico-riabilitativa ed assistenziale per persone a lungo
assistite dai Centri di Salute Mentale del D.S.M., non assistibili a domicilio
e richiedenti un alto livello di intervento sia terapeutico che assistenziale
non raggiungibile all'interno delle altre strutture del Dipartimento di Salute
Mentale. In relazione alle finalità proprie della struttura la Comunità
psichiatrica persegue i seguenti obiettivi: offrire ospitalità residenziale di
lungo periodo, prestare assistenza alle principali funzioni di base
dell'utente, erogare attività terapeutico-riabilitative individualizzate;
promuovere attività di socializzazione, elaborare progetti di reinserimento nel
tessuto sociale.
·
DAY
HOSPITAL PSICHIATRICO: è una struttura semiresidenziale, collegata al
Centro di Salute Mentale (C.S.M.), con attività sanitaria, terapeutica e
riabilitativa a breve e medio termine per progetti terapeutici
individualizzati. Ha la funzione di evitare ricoveri a tempo pieno, nonché di
limitarne la durata quando questi si rendono indispensabili. Si rivolge ad
utenti con psicopatologia sub-acuta, aventi necessità di interventi
farmacologici, psicoterapeutici e riabilitativi.
ALLEGATO B:
DOCUMENTO PROGRAMMATICO
ED ISTITUZIONALE DI PSICHIATRIA DEMOCRATICA
[ Minguzzi, G. F. et al. ] (1973). Documento programmatico
e progetto di statuto (non riportato per esteso) di Psichiatria Democratica,
Ottobre 1973.
PSICHIATRIA DEMOCRATICA
Dopo numerosi incontri avvenuti
nell'anno in corso un comitato di promotori (Franca Basaglia, Franco Basaglia,
Domenico Casagrande, Tullio Fragiacomo, Vieri Marzi, Gian Franco
Minguzzi, Piera Piatti, Agostino Pirella, Michele Risso, Lucio Schittar ,
Antonio Slavich , Franco Di Cecco) ha costituito a Bologna il primo nucleo di
un gruppo denominato "Psichiatria democratica", che si riconosce
nella analisi e nelle finalità espresse dall'allegato documento programmatico.
Il comitato promotore ha provveduto inoltre a stilare uno
statuto provvisorio, ed a nominare una segreteria provvisoria (...)
Bologna, 8 ottobre 1973
PSICHIATRIA
DEMOCRATICA
Documento programmatico
L'accettazione da parte di tutti
gli operatori psichiatrici della logica dell'internamento coincide con l'accettazione
dell'aggressione attuata ai danni degli internati. Agire in un'istituzione
psichiatrica o in servizi psichiatrici che mantengano questa logica - fondata
sulla netta separazione fra sano e malato e sulla strumentalizzazione del
malato implicita in questa separazione - deve portare gli operatori
psichiatrici che intendono opporcisi al rifiuto dell'istituzione come
organizzazione di custodia e di controllo. L'internamento
manicomiale e l'internamento carcerario sono risposta univoca e aspecifica ad
esperienze umane che esistono e che hanno origini e dovrebbero avere risposte
diverse: la malattia e la delinquenza. Queste esperienze umane,
tuttavia, nel nostro sistema sociale, non possono essere affrontate come tali,
perché esse sono annullate in una gestione repressiva che, forzandole in
un'unica modalità di organizzazione istituzionale, ne uniforma il destino
sociale. L'univocità della risposta è espressione dell'univocità di un giudizio
che definisce sia lo stato di "malattia" che quello di "delinquenza"
solo in rapporto all'organizzazione sociale: cioè come trasgressione dei limiti
di norma definiti. In pratica, il sistema sociale, mentre si rifà alle diverse
branche della scienza per proporre una differenziazione apparente fra le
diverse contraddizioni che deve affrontare, di fatto gestisce in modo univoco e
puramente difensivo la problematica della marginalità: l'unica realtà è
l'organizzazione in termini repressivi di una contraddizione che non può mai
essere vissuta come tale. "Terapia"
da un lato e "riabilitazione e rieducazione sociale" dall'altro sono
la giustificazione formale all'internamento, che è pratica incostituzionale perché
concretamente finalizzata alla distruzione dei cittadini che avrebbero bisogno
di terapia e di riabilitazione.
Compito dell'operatore psichiatrico è, dunque riportare alla propria
specificità un'istituzione e un rapporto che - sotto l'alibi di codificazioni
scientifiche diverse - prevedono invece solo la genericità del controllo.
Questo compito si attua attraverso la riappropriazione della funzione
terapeutica specifica di organismi sanitari che non hanno mai svolto un ruolo
terapeutico nei confronti della malattia mentale; e, al tempo stesso,
attraverso una "depsichiatrizzazione" di questi servizi, rendendo
esplicito il processo repressivo e discriminante che essi attuano e che con la
malattia non ha niente a che fare. Per
gli operatori ciò significa:
1) L'individuazione e la lotta contro il proprio ruolo di
potere nei confronti dell'utente del servizio.
2) L'individuazione nella persona di bisogni sociali non
soddisfatti, che l'internamento cancella, occultandoli sotto la diagnosi di
malattia.
3) L'individuazione degli strumenti terapeutici
impliciti nel proprio ruolo specifico, una volta liberato dalla
strumentalizzazione che il sistema sociale attua attraverso la
delega del controllo e del potere.
4) L'individuazione e il riconoscimento delle persone e delle
forze sociali coinvolte e da coinvolgere in questa lotta.
In questa ottica, il tecnico deve
offrire una pratica che serva di verifica a istanze politiche, non
solo sanitarie e tanto meno solo psichiatriche. Il gruppo di operatori
psichiatrici che intendono agire in questo senso non si prefigge di costituirsi
come gruppo politico, né potrebbe farlo. Esso presume, infatti, che la
politicità del suo agire consista nel proporre un terreno di confronto
reciproco per il tecnico e per il politico, attraverso la creazione di
situazioni alternative su cui si misuri un reale schieramento di classe,
arrivando a chiarificare i termini di una "lotta di classe" che,
all'interno della logica istituzionale, risultano spesso vaghi e sfuocati.
Se, ad esempio, gli internati appartengono alla stessa classe cui appartengono
infermieri e parte degli operatori, lo schieramento di questi ultimi a favore
della lotta per i primi è l'unico presupposto valido ad un allargamento della
lotta psichiatrica e del suo significato politico. Limitandosi, infatti, la
lotta al movimento di alcuni psichiatri che - pur in mezzo a difficoltà e
incomprensioni - continuano a dimostrare praticamente i momenti del processo di
strumentalizzazione della malattia a certi livelli sociali ed economici e la
funzione del manicomio dove non approda solo la malattia mentale ma ogni forma
di asocialità che ha bisogno di essere controllata, la battaglia si isterilisce
e si vanifica, riducendosi ad una proposta simbolica di ciò che potrebbero
essere un rapporto e un'istituzione terapeutici: la lotta si riduce, in tal
senso, ad una semplice trasformazione tecnica che lascia inalterate le
strutture di potere e la dinamica dell'oppressione.
Il
gruppo di psichiatria democratica si propone quindi di:
1) Continuare la lotta all'esclusione, analizzandone e
denunciandone le matrici negli aspetti strutturali (rapporti sociali di
produzione) e sovrastrutturali (norme e valori) della nostra società. Questa
lotta può essere condotta solo collegandosi con tutte le forze e i movimenti
che, condividendo tale analisi, agiscono concretamente per la trasformazione di
questo assetto sociale.
2) Continuare la lotta al "manicomio", come luogo
dove l'esclusione trova la sua espressione paradigmatica più evidente e
violenta, rappresentando insieme la garanzia di concretezza al riprodursi dei
meccanismi di emarginazione sociale. Anche se questa spesso passa per una lotta
di retroguardia, gli ospedali psichiatrici esistono, infatti, in tutto il paese
e, tranne rari casi in cui operatori psichiatrici o amministrazioni provinciali
stanno tentando un'opera di trasformazione, per la maggioranza la situazione è
immobile e immodificata.
3) Sottolineare i pericoli del riprodursi dei meccanismi
istituzionali escludenti, anche nelle strutture psichiatriche extra-manicomiali
di qualunque tipo. Qualsiasi struttura alternativa si configura infatti a
immagine e somiglianza dell'organizzazione istituzionale che continua ad
esistere in modo dominante alle sue spalle. Ogni artificiosa separazione
concorrenziale fra servizi di igiene mentale e ospedale psichiatrico è
funzionale alla riproposizione di alibi e nazionalizzazioni, ma non certo alla
prevenzione della esclusione manicomiale. Ciò non significa formulare riserve
nei confronti dei servizi psichiatrici autonomi nel territorio, così come
l'unificazione di questi servizi appare solo condizione necessaria ma non
sufficiente al fine che ci si prefigge: l'individuazione - sia nell'istituzione
ospedaliera che nel territorio - dei veri problemi, una volta liberati dalle
incrostazioni istituzionali, sociali, culturali e dai condizionamenti che alterano
e modificano la natura stessa della domanda.
4) Rendere praticamente esplicito il legame fra l'azione in
campo specifico psichiatrico e il problema più generale dell'assistenza medica,
rivendicando - al di della divisione del lavoro e delle competenze - un'azione
unitaria che dalla lotta specifica per la promozione della salute mentale ci
coinvolga nella più ampia battaglia per l'attuazione di una concreta e
necessaria riforma sanitaria che si fondi su una nuova logica sociale. E'
l'esigenza di questa nuova. logica sociale che deve impegnare il gruppo a
collegarsi con tutte le forze che perseguono concretamente il medesimo scopo.
ALLEGATO C:
“SPORCANDOSI LE MANI”:
CONFERENZA DI P.D. a Matera (2003)
ALLEGATO D:
MANIFESTO PER LA
SALUTE MENTALE,
IL C.O.R.E. DI
PSICHIATRIA DEMOCRATICA
Manifesto per la Salute
Mentale del 2000
Il C.O.R.E. di Psichiatria
Democratica
La promozione di pratiche
operative antistituzionali sviluppatesi in tante parti del Paese, ha dovuto
fare i conti negli ultimi trent'anni con poteri molto forti, ideologie e prassi
legate al controllo sociale ed alla costante negazione dell'individualità del
cittadino in difficoltà.
Pur tuttavia, per una miriade di
motivi, se da una parte lo sviluppo di una cultura per la promozione della
Salute Mentale si è andata progressivamente consolidando, dall'altro sul
territorio vengono riproposte, di sovente, metodologie di intervento uguali a
quelle che la psichiatria asilare aveva sostenuto e diffuso negli anni più bui
continuando ad utilizzare modalità e linguaggi tesi a rimarcare differenze fra
gli uomini e specificità del sapere medico e, quindi, a riproporre e riprodurre
separazione ed isolamento.
La Società Italiana di
Psichiatria Democratica, primaria protagonista di battaglie culturali,
civili e scientifiche, individua oggi in alcune chiare parole d'ordine linee di
continuità ed al tempo stesso di svolta. Le parole d'ordine sulle quali si
vogliono fonda-re le scelte di P.D. e che ne costituiscono la sua
identità, il suo codice genetico sono il frutto di un lungo lavoro di
riflessione e di pratiche sul campo, nella quotidianità delle relazioni e degli
scambi con i pazienti psichiatrici.
Difatti nel corso degli anni i
gruppi dirigenti, gli iscritti e quanti si richiamano alle nostre posizioni,
hanno favorito e promosso scambi e dibattiti con utenti, familiari, enti
locali, associazionismo, mondo dell'informazione, del lavoro, della giustizia,
della politica, della cultura, dei giovani, della scuola e del-l'economia così
da potere offrire, oggi, indicazioni capaci di fondere teoria e pratica e,
quindi, indicare un percorso credibile.
La Comunità
La Comunità deve diventare
sempre più luogo unico ed elettivo dove affrontare e risolvere il disagio nelle
sue variegate forme. L'opposizione netta, da parte della collettività, alla
creazione di luoghi separati e lontani dal contesto nel quale sia venuto a
svilupparsi il disturbo mentale, re-sta condizione e presidio contro ogni
ritorno al passato.
Soggetto ed oggetto di ogni intervento
psichiatrico, non può essere soltanto la persona sofferente, ma diventa la
comunità intera in un processo continuo di costruzione materiale di quei
diritti formalmente dati ma non esercitati e per-ciò da affermare.
La Comunità deve,
altresì, sempre più sviluppare la consapevolezza che la "cura" della
follia è un problema di tutti e, pertanto, la libertà dal bisogno economico,
così come il bisogno di un tetto e la necessità di utilizzare nuove risorse
professionali che accompagnino e sostengano il per-corso verso l'autonomia
possibile, sono una questione collettiva e non dei soli specialisti.
La Comunità, attivata
attraverso le diverse forme aggregative, potrà, così, liberarsi della diffusa e
radicata convinzione che vorrebbe la malattia mentale non solo inguaribile ma
anche incurabile. La Comunità, quindi, come luogo dove confrontarsi apertamente
su saperi e pratiche, come spazio permanente ed attivo dove trovano ascolto,
dignità quei cittadini che non ce la fanno da soli; luogo e spazio in cui il diritto
sia sostenuto e rinforzato attraverso il calore delle relazioni e degli
affetti.
La Comunità quale
speranza e sogno di tutti e di ognuno, come naturale sede di relazioni
significative, nella quale si garantisce e riserva a tutti la possibilità di
dibattere, riconoscere quanto si promuove o si intende promuovere.
La Comunità, in
conclusione dove ciascuno possa, a piene mani, prendersi o riprendersi la
propria libertà.
Opportunità
L'Opportunità significa
scelta, possibilità, negoziazione e salvaguardia dei diritti di cittadinanza.
II negare aprioristicamente, il
confinamento, la parzialità dei movimenti consentiti cui soggiacciono gli
utenti, debbono essere sostituiti da quello che oggi viene indicato come
l'empowerment, ovvero la possibilità di avere più opzioni. Bisogna invertire la
logica di una psichiatria che tende ancora a normalizzare la follia ed
attenuarne l'impatto sociale, creando nuove regole e nuovi modelli sia di
formazione che di funzionamento di quanti sono impegnati nel sistema Salute Mentale.
E, perciò, bisogna chiedersi per esempio: noi operatori della Salute Mentale,
allo stato, promuoviamo reali opportunità di libertà, indipendenza e riscatto?
Oppure stiamo favorendo, più o meno inconsapevolmente, la creazione di nuovi
ammortizzatori di tensioni sociali e la formazione di sottocategorie, così che
in nome di una presunta uguaglianza assistiamo all'immissione sul mercato di
manodopera a basso costo vanificando, così, il perseguimento del fondamentale
obiettivo della riproduzione sociale? Insomma il nuovo sapere e quindi il nuovo
agire messo in campo esprimono fino in fondo una vis antagonista al controllo
sociale o sono anch'esse, sin dalla loro proposizione e quindi prima ancora di
porsi come oggetto-progetto di cambiamento, funzionali alla logica
dell'implosione?
Opportunità, significa
per Psichiatria Democratica promozione di una capacità contrattuale, rendere
tangibili fatti e scelte del singolo e del gruppo, estensione della
soggettività nel collettivo.
Opportunità per P.D. significa
trasformare gli indicatori freddi finora utilizzati dalla psichiatria per
misurare il paziente e la sua vita - metri quadri per utente, costo e tipologia
del personale, costi di vitto e riscaldamento etc. - in indicatori caldi:
rispetto dei tempi e della differente modulazione degli atti della vita,
rispetto delle loro convinzioni, de-codificazione di una scienza astratta,
senz'anima e senza tempo. II paziente quale risorsa collettiva e non come
problema.
Noi di Psichiatria Democratica
vogliamo ancora sottolineare il significato di Opportunità, per i diversi
attori in campo: per i pazienti l'essere protagonisti e conoscitori del proprio
trattamento, dei tempi e degli esiti delle terapie cui si è sottoposti, essere
adeguatamente e puntualmente informati sui nuovi programmi dei Servizi e sui
livelli di partecipazione previsti; per i familiari essere costantemente
informati e coinvolti nelle attività di programmazione e dei trattamenti dei
loro con-giunti; per gli operatori essere protagonisti del proprio lavoro,
possedere tutte le risorse necessarie a sviluppare una formazione permanente,
avere la possibilità di confrontare le proprie decisioni e di essere attivatori
consapevoli di processi di cambiamento: per ogni paziente protagonista della
propria vita, ci vogliono operatori protagonisti del proprio lavoro.
Responsabilità
La Responsabilità
costituisce la condizione irrinunciabile per la realizzazione di ogni buona
pratica di Salute Mentale. Ma il termine Responsabilità non può essere confuso
con quello di efficientismo, perché nello sviluppo del pensiero e delle
pratiche di Psichiatria Democratica esso ha un significato ben più articolato.
Esso significa, innanzitutto, promozione della condivisione di program-mi,
progetti, attese e speranze delle persone che si rivolgono ai nostri Servizi,
significa ancora oggi, per P.D., sostenere e promuovere in ogni dove processi
autentici di deistituzionalizzazione.
Deistituzionalizzazione
significa "partire dalla realtà" per costruire percorsi sociali ed
istituzionali di trasformazione, creando processi cultura-li, scelte, idee,
intenzionalità che cambino quelle pratiche psichiatriche assestate nel compito
di "erogazioni di risposte".
Responsabilità come
estensione dei propri compiti senza che questi assumano il significato di
invasione indistinta dei compiti di altri. Responsabilità come capacità di
ascoltare, ma anche scambio continuo tra il sanitario il sociale e tutte le
diversità che dal suo corpo sono state escluse o allontanate o separate.
Responsabilità come
percorso possibile che dalle istituzioni vuole ricondurre le diversità ad
essere accolte in un corpo sociale ricreato; sono risorse le componenti
affettive dei rapporti, le competenze e le esperienze soggettive di tutti
(operatori ed utenza), le energie e le creatività individua-li, la qualità del
lavoro, il reticolo degli scambi e dei rapporti dell'universo riproduttivo.
E' Responsabilità , per
tutti, dare voce al silenzio e al non detto delle storie vere e concrete delle
persone, delle loro condizioni di vita, problemi, modi di essere e di soffrire,
assolutamente individuali. Responsabilità, da ultimo, è favorire la
cittadinanza attraverso il riconoscimento del ruolo che non è affatto una
valenza del possibile ma quella più concreta del-l'esserci. Ecco perché riconiugare
i poteri con i saperi ci aiuterà a fare ridefinire la sofferenza oltre la
clinica.
Etica
Bisogna porre con forza, con e
nella questione psichiatrica la questione Etica.
La comunanza di valori di
eticità è elemento coesivo e fondante di ogni forma di socialità che tutela
l'interesse comune, in particolare quello dei più deboli. Per-tanto, è
d'obbligo attivarsi per riempire il vuoto che circonda la questione
psichiatrica in termini di risorse e di investimenti, con nuovi codici di
comportamento e nuovi modelli di pensiero che facciano emergere dalle aride
statistiche economico-finanziarie "l'anima".
Nel sistema Salute Mentale,
etico ed ermeneutico è l'attenzione al quotidiano dei pazienti gravi, troppo
spesso abbandonati dai servizi in nome di "pensieri deboli" e del
falso rispetto per le scelte individuali.
Etica è dare ascolto ad ogni
forma di sofferenza, senza "dissociare" le persone con l'uso di
linguaggi che li allontanano dai loro mondi e dalle loro esistenze.
Etica è mettere al bando dalle
pratiche ogni forma di violenza, dal mancato rispetto negli elementari rapporti
interpersonali, fino ai fili ed alle scariche di un ESK, od alle forme di
contenzione ancora presenti in tante strutture di ricovero.
Etica è non propugnare un
rimedio peggiore del male: ci riferiamo a quelle pagine, sempre più numerose,
di quotidiani, media, TV che in maniera invadente - utilizzano ogni forma di
disagio per trasformarlo in qualcosa che deve essere immediatamente rimosso ed
annullato.
Da sempre abbiamo creduto e lottato
perché la felicità passasse attraverso i colori, i sapori, i pro-fumi e gli
affetti della vita e non attraverso pillole della felicità o similari che
riempiono i fogli di trattamento di troppi specialisti.
Etica è prima di tutto
una formazione permanente sul campo che, con un meccanismo di feedback,
verifica le ipotesi e le traduce in un modello operativo adeguato al contesto.
Etica è lavorare per la
liberazione dell'uomo, di tutti gli uomini.
Dott. Emilio Lupo
Segretario Nazionale di Psichiatria Democratica .
ALLEGATO E:
LETTERA DI DIMISSIONI
DI LOREN R. MOSHER
Lettera di dimissioni di Loren R.
Mosher (psichiatra) dalla American Psychiatric Association, l’associazione
degli psichiatri negli Usa. Loren R. Mosher è stato l'ideatore e il direttore
delle cliniche Soteria, sperimentazione d'avanguardia mondiale (cliniche in
Usa, in Svizzera e altrove) in campo psichiatrico. Le dimissioni sono per il contrasto sostanziale di Mosher (e
dello spirito delle sue cliniche Soteria, non farmacologiche) con la
psichiatria ufficiale (quale organizzata nella American Psychiatric Association)
con le industrie farmaceutiche, con la teoria biologica sulla malattia mentale
e con la concezione secondo la quale gli psicofarmaci sono da considerarsi come
modo principe di cura.
|
Lettera di Dimissioni
dalla American Psychiatric Association
4 dicembre 1998
Loren R. Mosher, dott. in Med. a Rodrigo Munoz, dott.
in Med., Presidente della American Psychiatric Association (APA)
Caro Rod,
Dopo circa tre decadi che sono socio, con un misto di
dispiacere e sollievo le invio la presente lettera di dimissioni dalla
American Psychiatric Association. La ragione principale per questa mia azione
è la certezza che con ciò mi sto dimettendo anche dalla American
Psychopharmacological Association. E’ una fortunata coincidenza che le due
organizzazioni, in verità identiche, abbiano anche lo stesso acronimo.
Sfortunatamente infatti, APA riflette, e rafforza, a
parole e a fatti, la nostra società farmaco-dipendente. E, anche, favorisce
la guerra dei profitti sui “farmaci”. Pazienti con una “doppia diagnosi” sono
infatti un problema per la professionalità, ma non per questo noi non
prescriviamo medicine sempre “buone”. Sono “cattivi” farmaci, essenzialmente,
solo quelli che non hanno bisogno di ricetta. Un marxista osserverebbe che
dato che l’APA è una organizzazione capitalista, l’APA adotterà
prevalentemente quei farmaci da cui può trarre guadagno –diretto o indiretto
-.
L’appartenere a questo gruppo non fa per me. A questo
punto della sua storia, secondo me, la psichiatria è stata pressoché
completamente comprata dalle compagnie farmaceutiche. L’APA non potrebbe
continuare senza il supporto di incontri, simposi, riunioni di lavoro,
pubblicità sulle riviste specializzate, gran giri di pranzi, borse di studio
a josa ecc. ecc. , fornito dalle compagnie farmaceutiche. Gli psichiatri sono
diventati i beniamini delle campagne promozionali delle compagnie
farmaceutiche. L’APA, ovviamente, dichiara che la sua indipendenza ed
autonomia non sono compromesse da questa situazione avviluppante. Una
qualunque persona dotata di un minimo di senso comune assistendo ai meeting
annuali osserverebbe invece che le esposizioni dei prodotti delle compagnie
farmaceutiche e i “simposi sponsorizzati dall’industria” attirano folle di
congressisti con le loro varie forme di allettamento mentre le sessioni
scientifiche sono a malapena seguite. L’istruzione psichiatrica subisce
ugualmente l’influenza dell’industria farmaceutica: la parte più importante
del curriculum dei praticanti è l’arte e la quasi scienza di aver a che fare
con gli psicofarmaci, cioè lo scrivere ricette.
Queste limitazioni psicofarmacologiche al nostro essere
medici completi limita anche il nostro orizzonte intellettuale. Non più
cerchiamo di comprendere la persona nella sua interezza e inserita nel suo
contesto sociale – piuttosto stiamo a riallineare i neurotrasmettitori dei
nostri pazienti. Il problema è che è molto difficile avere un
rapporto di relazione con un neurotrasmettitore- qualsiasi sia la sua
configurazione. Così, la nostra acuta Organizzazione ci fornisce spiegazioni,
basate sulla sua concezione neurobiologica di fondo, che ci tengono distanti
da quei conglomerati di molecole che siamo arrivati a definire come pazienti.
Promuoviamo il largo uso e ci perdoniamo l’abuso di sostanze chimiche
tossiche nonostante sappiamo che producono seri effetti di lungo periodo –
discinesia tardiva, demenzia tardiva e preoccupanti sindromi di
astinenza.
Ora, dovrei io essere succube delle compagnie
farmaceutiche che trattano molecole nelle loro formulazioni? No, grazie
tante. Mi dispiace che dopo essere stato psichiatra per 35 anni debba
decidere di dissociarmi da questa Associazione. Ma essa non rappresenta
affatto il mio interesse. Non sono capace di ottenere niente dall’attuale
modello riduzionista medico-biologico strombazzato dalla ledership
psichiatrica che ancora una volta ci sposa alla medicina somatica. Qui si
tratta di moda, politica e, in quanto connessione con l’industria
farmaceutica, soldi.
Per giunta, l’APA ha stretto un’indecente alleanza con il
NAMI [n.d.t: National Alliance of Mentally Ills, potente associazione di
genitori e parenti di pazienti psichiatrici in Usa] (non ricordo se ai soci è
stato chiesto di approvare tale alleanza) cosicché le due organizzazioni
hanno adottato pubblicamente lo stesso credo circa la natura della pazzia.
Nel mentre che si professa “nell’interesse del paziente”, in realtà l’APA
difende i non-pazienti, i genitori, nel loro desiderio di tenere sotto controllo,
tramite una sottomissione rafforzata legalmente, i loro rampolli
cattivi/matti : il NAMI con la tacita approvazione dell’APA, ha adottato una
procedura abbreviata di obbligo istituzionalizzato di somministrazione di
psicofarmaci neurolettici, procedura che viola i diritti civili dei loro
rampolli. La maggior parte di noi sta a guardare e permette questa procedura
di intervento fascista. Il dio della psichiatria, Dott. E. Fuller Torrey è
autorizzato a fare una diagnosi e a consigliare il trattamento a coloro,
dell’organizzazione NAMI, con cui è professionalmente in disaccordo.
Chiaramente una violazione dell’etica medica. L’APA protesta? Ovviamente no,
perché si tratta di cose con cui l’APA è d’accordo, ma esplicitamente non può
appoggiare. Gli si permette di mettersi in vista; d’altronde non è più un
membro dell’APA. (parola ingegnosa APA!). La miopia di questo matrimonio tra
l’APA, il NAMI e le società farmaceutiche (che con gioia supportano entrambi
i gruppi a causa della loro sbandierata presa di posizione pro-psicofarmaci)
è un abominio. Io non voglio far parte di una psichiatria dell’oppressione e
del controllo sociale.
“Malattia mentale a base biologica” è certamente
conveniente per i familiari e ugualmente per i medici. Non c’è nessuna
assicurazione di garanzia contro errori, non responsabilità personale.
Siamo stati tutti presi senza colpa in una turba di patologia cerebrale di
cui nessuno, eccetto il DNA, è responsabile. Orbene, tanto per cominciare,
qualsiasi malanno che abbia una specifica patologia del cervello
anatomicamente definita diventa campo della neurologia (la sifilide è un buon
esempio). Così, per essere coerenti col punto di vista “malattia del
cervello”, tutti i principali disordini psichiatrici diverrebbero territorio
dei nostri colleghi neurologi. Pur senza averli consultati, ritengo che essi
neurologi rifuggano di prendersi carico di queste problematiche di individui.
Però la conseguenzialità delle nostre teorie richiederebbe di passare le da
noi scoperte “malattie biologiche del cervello”, a loro. A questo punto è
ovvio e irrilevante che non ci siano evidenze confermanti la diagnosi di
malattia del cervello. Perché quello con cui qui si ha a che fare è moda,
politica e soldi. Il livello di disonestà scientifica ed intellettuale è diventato
troppo alto perché io possa ancora sopportare di essere socio.
E’ senza sorpresa che vedo che la specializzazione in
psichiatria è poco ambita dagli studenti nelle università americane. Questo
ci dovrebbe far riflettere sullo stato della psichiatria di oggi. Implica –
che almeno in parte essi vedono la psichiatria come limitata e subente. A me
appare chiaro che ci siamo intestarditi su una situazione in cui, ad
eccezione degli accademici, la maggior parte dei medici psichiatri non ha una
concreta relazione – così vitale nel processo di guarigione – con gli
individui disturbati e disturbanti che trattano. Il solo ruolo concreto è
quello di scrittori di ricette –contabili con l’apparenza di “salvatori”.
Infine, come può l’APA pretendere di conoscere più di quel
che sa? Il DSM IV è la costruzione sulla cui base la psichiatria cerca di
essere accettata dalla medicina in generale. Ma gli addetti ai lavori sanno
che è molto più un documento politico che scientifico. Parla bene di sé
stesso cosicché – per quanto la breve apologia di sé è raramente notata. Il
DSM IV è diventato una bibbia e un best seller che produce moneta - i suoi
maggiori difetti non si vedono. Esso delimita e delinea la pratica medica,
alcuni lo prendono seriamente, altri con più realismo. E’ la via per ottenere
l’onorario. E’ facile ottenerne delle diagnosi ripetibili in progetti di
ricerca. Il punto è cosa ci dicono le sue categorie? Rappresentano esse
effettivamente la persona con problemi? Non lo fanno, e non possono farlo,
perché non ci sono criteri esterni convalidanti le diagnosi psichiatriche.
Non c’è né un test del sangue, né lesioni anatomiche specifiche per nessuno
dei maggiori disordini psichiatrici. Così, dove andiamo a parare? L’APA come
organizzazione si è implicitamente (talvolta anche esplicitamente) acquistata
una parvenza teorica. E’ la psichiatria – quella praticata adesso – una
parvenza, un trucco? Sfortunatamente la risposta è essenzialmente si.
Che cosa raccomando all’Organizzazione al momento di
lasciarla dopo averla praticata per trent’anni?
Soprattutto, essere noi proprio. Non fare alleanze
infelici e senza il permesso dei membri.
Essere veri sulla scienza, la politica, i soldi. Chiamare
ogni cosa per quel che è – cioè essere onesti.
Uscir fuori dal letto del NAMI e delle compagnie
farmaceutiche. L’APA dovrebbe allinearsi, senza retorica, con gli autentici
gruppi di utenti, cioè gli ex pazienti, i sopravvissuti psichiatrici, etc.
Discutere su chi dirige. Personalmente non ne vedo nessuno
buono.
Mi sembra che abbiamo dimenticato il principio base – la
necessità di essere orientati verso la soddisfazione del paziente/cliente/utente.
Ricordo sempre il detto di Manfred Bleuler: “Loren, ricordati sempre
che sei un impiegato assunto dai tuoi pazienti.” Alla fine sono essi
che stabiliranno se o no la psichiatria sopravviverà nel mercato dei
servizi.
Fonte: http://www.nopazzia.it/LRMosher/dimissioni.htm
|
Letter of Resignation
from the American Psychiatric Association
4 December 1998
Loren R.
Mosher, M.D. to Rodrigo
Munoz, M.D., President of the American Psychiatric Association (APA)
Dear Rod,
After nearly three decades as a member it is with a mixture of pleasure
and disappointment that I submit this letter of resignation from the American
Psychiatric Association. The major reason for this action is my belief that I
am actually resigning from the American Psychopharmacological Association.
Luckily, the organization’s true identity requires no change in the acronym.
Unfortunately, APA reflects, and reinforces, in word and deed, our drug
dependent society. Yet it helps wage war on “drugs”. “Dual diagnosis” clients
are a major problem for the field but not because of the “good” drugs we
prescribe. “Bad” ones are those that are obtained mostly without a
prescription. A Marxist would observe that being a good capitalist
organization, APA likes only those drugs from which it can derive a
profit—directly or indirectly.
This is not a group for me. At this point in history, in my view,
psychiatry has been almost completely bought out by the drug companies. The
APA could not continue without the pharmaceutical company support of
meetings, symposia, workshops, journal advertising, grand rounds luncheons,
unrestricted educational grants etc. etc. Psychiatrists have become the
minions of drug company promotions. APA, of course, maintains that its
independence and autonomy are not compromised in this enmeshed situation.
Anyone with the least bit of common sense attending the annual meeting would
observe how the drug company exhibits and “industry sponsored symposia” draw
crowds with their various enticements, while the serious scientific sessions
are barely attended. Psychiatric training reflects their influence as well:
the most important part of a resident’s curriculum is the art and
quasi-science of dealing drugs, i.e., prescription writing.
These psychopharmacological limitations on our abilities to be complete
physicians also limit our intellectual horizons. No longer do we seek to
understand whole persons in their social contexts—rather we are there to
realign our patients’ neurotransmitters. The problem is that it
is very difficult to have a relationship with a neurotransmitter—whatever its
configuration. So, our guild organization provides a rationale, by its
neurobiological tunnel vision, for keeping our distance from the molecule
conglomerates we have come to define as patients. We condone and promote the
widespread use and misuse of toxic chemicals that we know have serious long
term effects—tardive dyskinesia, tardive dementia and serious withdrawal
syndromes.
So, do I want to be a drug company patsy who treats molecules with their
formulary? No, thank you very much. It saddens me that after 35 years as a
psychiatrist I look forward to being dissociated from such an organization.
In no way does it represent my interests. It is not within my capacities to
buy into the current biomedical-reductionistic model heralded by the
psychiatric leadership as once again marrying us to somatic medicine. This is
a matter of fashion, politics and, like the pharmaceutical house connection,
money.
In addition, APA has entered into an unholy alliance with NAMI (I don’t
remember the members being asked if they supported such an association) such
that the two organizations have adopted similar public belief systems about
the nature of madness. While professing itself the “champion of their
clients” the APA is supporting non-clients, the parents, in their wishes to
be in control, via legally enforced dependency, of their mad/bad offspring:
NAMI with tacit APA approval, has set out a pro-neuroleptic drug and easy
commitment-institutionalization agenda that violates the civil rights of
their offspring. For the most part we stand by and allow this fascistic
agenda to move forward. Their psychiatric god, Dr. E. Fuller Torrey, is
allowed to diagnose and recommend treatment to those in the NAMI organization
with whom he disagrees. Clearly, a violation of medical ethics. Does APA
protest? Of course not, because he is speaking what APA agrees with, but
can’t explicitly espouse. He is allowed to be a foil; after all - he is no
longer a member of APA. (Slick work APA!) The shortsightedness of this
marriage of convenience between APA, NAMI, and the drug companies (who
gleefully support both groups because of their shared pro-drug stance) is an
abomination. I want no part of a psychiatry of oppression and social control.
“Biologically based brain diseases” are certainly convenient for families
and practitioners alike. It is no fault insurance against personal
responsibility. We are all just helplessly caught up in a swirl of brain
pathology for which no one, except DNA, is responsible. Now, to begin with,
anything that has an anatomically defined specific brain pathology becomes
the province of neurology (syphilis is an excellent example). So, to be
consistent with this “brain disease” view all the major psychiatric disorders
would become the territory of our neurologic colleagues. Without having
surveyed them I believe they would eschew responsibility for these
problematic individuals. However, consistency would demand our giving over
“biologic brain diseases” to them. The fact that there is no evidence
confirming the brain disease attribution is, at this point, irrelevant. What
we are dealing with here is fashion, politics and money. This level of
intellectual /scientific dishonesty is just too egregious for me to continue
to support by my membership.
I view with no surprise that psychiatric training is being systematically
disavowed by American medical school graduates. This must give us cause for
concern about the state of today’s psychiatry. It must mean—at least in part
that they view psychiatry as being very limited and unchallenging. To me it
seems clear that we are headed toward a situation in which, except for
academics, most psychiatric practitioners will have no real, relationships—so
vital to the healing process—with the disturbed and disturbing persons they
treat. Their sole role will be that of prescription writers—ciphers in the
guise of being “helpers”.
Finally, why must the APA pretend to know more than it does? DSM IV is
the fabrication upon which psychiatry seeks acceptance by medicine in
general. Insiders know it is more a political than scientific document. To
its credit it says so—although its brief apologia is rarely noted. DSM IV has
become a bible and a money making best seller—its major failings
notwithstanding. It confines and defines practice, some take it seriously,
others more realistically. It is the way to get paid. Diagnostic reliability
is easy to attain for research projects. The issue is what do the categories
tell us? Do they in fact accurately represent the person with a problem? They
don’t, and can’t, because there are no external validating criteria for
psychiatric diagnoses. There is neither a blood test nor specific anatomic
lesions for any major psychiatric disorder. So, where are we? APA as an
organization has implicitly (sometimes explicitly as well) bought into a
theoretical hoax. Is psychiatry a hoax—as practiced today? Unfortunately, the
answer is mostly yes.
What do I recommend to the organization upon leaving after experiencing
three decades of its history?
1. To begin with, let us be ourselves. Stop taking on unholy alliances
without the members’ permission.
2. Get real about science, politics and money. Label each for what it is—that
is, be honest.
3.Get out of bed with NAMI and the drug companies. APA should align itself,
if one believes its rhetoric, with the true consumer groups, i.e., the
ex-patients, psychiatric survivors etc.
4.Talk to the membership—I
can’t be alone in my views.
We seem to have forgotten a basic principle—the need to be
patient/client/consumer satisfaction oriented. I always remember Manfred
Bleuler’s wisdom: “Loren, you must never forget that you are your patient’s
employee.” In the end they will determine whether or not
psychiatry survives in the service marketplace.
|
ALLEGATO F :
CARTA DEI DIRITTI DEI
MALATI MENTALI
“La Carta dei
diritti proposta dalla CGIL recentemente ed in maniera autorevole, a
Roma, ci è di grande aiuto per costruire un ampio fronte che, partendo proprio
dai diritti agiti, rompa il muro dell’omertà, delle connivenze e degli abusi
perpetrati a danno dei più deboli “
(Lupo, 2000).
La Carta dei Diritti per
la Salute Mentale della Fp Cgil
CARTA DEI DIRITTI DEGLI UTENTI
DIRITTO AD ESSERE INFORMATO sul disturbo mentale,
sulle prospettive, sui trattamenti, sulle eventuali alternative e sulle
prevedibili conseguenze delle scelte operate. L’informazione deve essere
espressa in modo semplice e chiaro, adeguato alla situazione, tale da essere
facilmente comprensibile, al fine di promuovere la massima adesione al
trattamento. L’informazione a terzi è ammessa solo con il consenso
esplicitamente espresso dall’utente e i dati personali devono essere tutelati
in relazione alla disciplina della privacy introdotta con la legge 675 del
1996.
DIRITTO AL CONSENSO
PERSONALE al trattamento che deve
essere dato in modo libero, spontaneo, consapevole e attuale. Si può
prescindere dal consenso solo quando previsto dalla legge, ed in particolare
nel caso di trattamento sanitario obbligatorio e di stato di necessità.
DIRITTO ALLA CARTA DEI
SERVIZI Ogni Dipartimento di Salute
Mentale deve adottare la carta dei servizi con l’impegno di attuare un efficace
sistema di informazione sulle prestazioni erogate e sulle modalità di accesso,
e con l’indicazione per la raccolta e l’analisi dei segnali di disservizio e
per il monitoraggio della soddisfazione degli utenti.
DIRITTO AL
TRATTAMENTO MIGLIORE POSSIBILE in relazione alle conoscenze scientifiche ed
ai servizi previsti dal progetto obbiettivo tutela della salute mentale.
L’approccio alla persona con disagio mentale deve essere globale e, ove
necessario, con interventi integrati di carattere psicologico, sociale e
biologico.
DIRITTO A NON ESSERE
CONTENUTO e a non subire azioni
lesive della propria integrità fisica e della propria dignità.
DIRITTO A NON
ESSERE ISTITUZIONALIZZATO La logica
manicomiale deve essere superata in tutte le strutture psichiatriche pubbliche
e private e a tal fine devono essere adottati
strumenti di monitoraggio, idonei indicatori di qualità e progetti
individualizzati. Il Dipartimento di Salute Mentale deve realizzare
l’integrazione tra il territorio e l’ospedale, con centralità del centro di
salute mentale e limitazione dei posti letto ospedalieri.
DIRITTO ALLA
CITTADINANZA Le persone con disagio
mentale devono avere accesso a tutti i servizi sociali essenziali ed in primo
luogo ad uno spazio abitativo e ad un inserimento lavorativo, utilizzando anche
la cooperazione sociale.
DIRITTO ALLA
PARTECIPAZIONE Le Regioni devono garantire la partecipazione – secondo
precise e specifiche modalità – delle associazioni dei familiari, degli utenti,
dei cittadini, del volontariato e delle altre forma associative impegnate nella
tutela del diritto alla salute mentale, nelle attività relative alla
programmazione, al controllo e alla valutazione dei servizi psichiatrici sia a
livello regionale che aziendale.
CARTA DEI DIRITTI DELLE OPERATRICI E DEGLI
OPERATORI
DIRITTO ALLE
RISORSE strutturali e finanziarie per
rispondere ai bisogni di salute mentale dei cittadini, con garanzia almeno del
5% dei fondi sanitari regionali per le attività dei Dipartimenti di Salute
Mentale.
DIRITTO ALLA
PARTECIPAZIONE per la costruzione
delle linee gestionali e cliniche del proprio servizio, con modalità efficaci,
strumenti certi e luoghi definiti.
DIRITTO AL RISPETTO
DELLE DOTAZIONI ORGANICHE ed al loro
adeguamento, quale strumento indispensabile per erogare un servizio ottimale al
fine di dare le risposte dovute a chi soffre di disturbi psichici e alle loro
famiglie, a partire dalle problematiche presentate in età evolutiva.
DIRITTO AL
CONTRATTO INTEGRATIVO con la
valorizzazione del ruolo svolto e delle diverse figure professionali in una
logica dipartimentale.
DIRITTO ALLA
FORMAZIONE ed aggiornamento continuo,
correlati alla operatività sul campo, come sostegno indispensabile alla
programmazione ed alla qualificazione dei servizi, in particolare nell’ambito
della prevenzione.
DIRITTO AL LAVORO
IN EQUIPE con la condivisione delle
attività tra le diverse figure professionali e con l’integrazione di saperi e
competenze in una ottica dipartimentale.
DIRITTO AL LAVORO
INTEGRATO tra operatori pubblici e della cooperazione sociale, delle fondazioni,
sanità privata ed altri, nella chiarezza dei ruoli e delle responsabilità, e
nel rispetto delle normative vigenti per la tutela di tutto il personale.
DIRITTO ALLA TUTELA
DELLA SICUREZZA sui luoghi di lavoro
con la reale applicazione del D. Lgs. 626/94 in tutti i servizi e pubblici e
privati e per tutte le attività, anche attraverso la valutazione dei rischi
psicologici e l’eventuale utilizzazione dello strumento della mobilità.
(Fonte: http://www.consulta-salutementale.it/docum_1.htm)
BIBLIOGRAFIA
Amerio, P. (1995). Fondamenti di psicologia sociale.
Bologna: Il Mulino.
Amerio, P. (2000). Psicologia di comunità. Bologna: Il
Mulino.
Angell, M. Is
Academic Medicine for Sale?, The New
England Journal of Medicine, May 18, 2000.
Attenasio, L. (A cura di). (2000). Fuori norma. La diversità come valore e
sapere. Roma: Armando Editore.
Bara, B. G. (A cura di). (1996). Manuale di psicoterapia cognitiva.
Torino: Bollati Boringhieri, 2003.
Bateson, G. (1972). Verso un’ecologia della mente. Milano:
Adelphi, 1976.
Bergeret, J. (1974). La personalità normale e patologica.
Milano: Cortina, 1984.
Bowen, M. (1979). Dalla famiglia all’individuo. Roma:
Astrolabio.
Brustia Rutto, P. (2001). Lezioni di psicologia dinamica: Sigmund
Freud. Torino: Bollati Boringhieri.
Byng-Hall, J. (1995). Attaccamento sicuro e cambiamento sistemico.
Milano: Cortina 1998.
Canetti, E. (1972). Potere e
sopravvivenza. Milano: Adelphi, 1994.
Canosa R., Storia del manicomio in Italia
dall’unità ad oggi, Milano : Feltrinelli, 1979.
Carli, L. (A cura di). (1999). Dalla diade alla famiglia. I legami di
attaccamento nella rete familiare. Milano: Cortina.
Castelfranchi, C. & Henry, P.
& Pirella, A. (1999). L’invenzione
Collettiva. Torino: Edizioni Gruppo Abele.
Ceruti, M. (1996). Il vincolo e la possibilità. Milano:
Feltrinelli.
Corradi Fiumara, G. (2003). La vita affettiva della mente. Torino:
Bollati Boringhieri.
Cotinaud, O. (1976). Dinamica di gruppo e analisi delle
istituzioni. Roma: Borla.
De Piccoli, N. & Lavanco, G.
(2003). Setting di comunità. Milano:
Unicopli.
Doise, P. & Palmonari, A. (A cura di). (1988). Interazione sociale e sviluppo della persona. Bologna: Il Mulino.
Elkind, D. (1994). Legami che stressano. Roma: Armando
Editore.
Fonzi, A. (A cura di). (2001). Manuale di psicologia dello sviluppo.
Firenze: Giunti.
Freud, S. (1901a). Psicopatologia della vita quotidiana. in
Opere, vol. IV. Torino : Bollati Boringhieri, 1970.
Freud, S. (1929). Il disagio della civiltà, vol. X. Torino: Boringhieri, 1978.
Gabbard, G. O. (1992). Psichiatria psicodinamica. Milano:
Cortina, 2002.
Giddens, A. (1995). La trasformazione dell’intimità.
Bologna: Il Mulino.
Goffman, E. (1961). Asylums. Le istituzioni totali. Torino: Einaudi,
1968.
Kaneklin,
C. (1993). Il gruppo in teoria e in
pratica. Milano: Cortina.
Lebovici,
S. (1994). The Way to Subjectification. Infant
Mental Health Journal, 15, 1: 50-56.
Liberman, R.P. La
riabilitazione psichiatrica. Milano: Raffaello
Cortina, 1997.
Lis, A. & Stella, S. &
Zavattini, G.C. (1999). Manuale di
psicologia dinamica. Bologna: Il Mulino.
Malagoli Togliatti, M. & Telfner,
U. (A cura di). (1991). Dall’individuo al
Sistema. Torino: Bollati Boringhieri.
Margaron, H. (2001). Le stagioni degli dei. Milano: Cortina.
Minguzzi, G. F. et al. (1973). Documento programmatico e progetto di statuto di Psichiatria
Democratica. <Psichiatria Democratica.com>. 1973.
Mullis, K. (2000). Ballando nudi nel campo della mente.
Milano: Baldini & Castoldi .
Petrella, F. (1986). Crisi
dell’istituzione psichiatrica e psicoanalisi. The Practitioner Edizione Italiana, 94, 19-23.
Ramella Benna, S. (2004). Educare
alla comunità: appartenenza, partecipazione e solidarietà. In Iaccone, A. &
Longobardi, C. (A cura di). Lineamenti di psicologia scolastica. Percorsi
educativi dalla prescuola alla scuola dell’obbligo. Milano: Franco Angeli.
Relazione al Congresso Nazionale
della Società degli Psicologi Italiani. (1991). Modelli culturali e
rappresentazioni soggettive della dipendenza. San Marino.
Rigliano, P. (A cura di). (1998). Indipendenze. Alcool e cibo, farmaci e
droghe, comportamenti di rischio e d’azzardo: le relazioni di dipendenza.
Torino: Edizioni Gruppo Abele.
Rosenfeld,
H. (1965). Stati psicotici. Roma:
Armando, 1973.
Selvini Palazzoli, M. & Cirillo,
S. & Sorrentino, A.M. (1988). I
Giochi Psicotici della Famiglia. Milano: Cortina.
Skinner, B. F. (1971). Al di là della libertà e della dignità.
Milano: Mondadori, 1973.
Sullivan, S. (1967). Il colloquio psichiatrico. Milano:
Feltrinelli.
Szasz, T. (1960). Il mito della malattia mentale. Milano:
Il Saggiatore, 1966.
Tanzi, E. (1905). Trattamento delle malattie mentali.
Milano: Società Editrice Libraria.
The Lancet , Depressing research,
, vol. 363, number 9418, 24 april 2004.
Ugazio, V. (1998). Storie permesse, storie proibite. Polarità
semantiche familiari e psicopatologia. Torino: Bollati Boringhieri, 2001.
Valenstein, E. Blaming the Brain, The
truth about Drugs and Mental Health, New York: The Free Press, 1998.
Valente Torre, L. & Freilone, F.
(1996). Elementi di psicopatologia
clinica e psicodiagnostica. Torino: UTET.
Veglia, F. (1999). Storie di vita. Narrazione e cura in
psicoterapia cognitiva. Torino: Bollati Boringhieri, 2003.
Watzlawick,
P. & Beavin, J. H. & Jackson, D.D. (1967). Pragmatica della comunicazione umana.
Studio dei modelli interattivi, delle patologie e dei paradossi. Roma: Astrolabio, 1971.
Zani, B. (2000). Le vie del benessere. Roma: Carocci Editore.
Zucca Alessandrelli, C. (1980). La
malattia della differenza: l’indifferenza.
Gli Argonauti, 12, 5-21.
Zucca Alessandrelli, C. (2002). Dare
senza dare. La dimensione amorosa in psicoanalisi: tra reale e virtuale. Gli Argonauti, 95: 283-298.
Zucca Alessandrelli, C. (2003). Tempo
e memoria. Gli Argonauti, 97:101-115.
Siti internet
Amenta, D. Bimbi depressi o iperattivi: basta una
pillola? Articolo pubblicato su L’Unità, 6 gennaio 2003. www.unità.it
Canosa, R. I nuovi soggetti del cambiamento. Atti
del Convegno Nazionale di Psichiatria Democratica, Vico-Equense (Na), 9-10-11
novembre 2000. http://www.psichiatriademocratica.com/congresso/congresso/Intervento%20Rocco.htm.
Canosa, R. Psichiatria Democratica ha trent’anni: la
storia, le battaglie contro l’esclusione, le lotte per i diritti, i nuovi
impegni. Atti del Convegno di Psichiatria Democratica, Matera, 13-14-15,
novembre 2003. http://www.psichiatriademocratica.com/ITALIA/16lucania/30PD/RELAZIONE-CANOSA.htm.
Canosa, R. e
Lupo, E. Psichiatria Democratica: la
guerra dei trent’anni. Articolo pubblicato su L’Unità, 13 novembre 2003. www.unità.it
Canosa, R. e Lupo, E. Psicofarmaci: le ragioni del più forte.
Atti del Convegno Internazionale Farmaci e Salute Mentale, Roma, 14 maggio 2004.
http://www.psichiatriademocratica.com/recensioni/Farmacisalutementale.htm
Di Vittorio, P. e Genchi, M. “Psichiatria Democratica al Forum Sociale
Europeo di Parigi”, 2003.http://www.psichiatriademocratica.com/recensioni/FSE-Parigi.htm.
Lalli, N. La psichiatria e la psicoterapia in Italia.
1997. http://www.nicolalalli.com/consultazione/italia.pdf
Lupo, E. Psichiatria Democratica forza di trasformazione.
Atti del Convegno Nazionale di Psichiatria Democratica, Vico-Equense (Na),
9-10-11 novembre 2000. http://www.psichiatriademocratica.com/congresso/congresso/PD%20LUPO%20VICO.htm
Lupo, E. Intervista di Gennaro Esposito. http://www.pol-it.org/ital/180/lupo.htm
Lupo,
E. E ora puntiamo a deistituzionalizzare
cpt e carceri.Articolo pubblicato su Il Manifesto, 14 novembre 2003. http://www.psichiatriademocratica.com/Il-Manifesto14-11-2003.htm
Pirella, A. Giornata mondiale della salute mentale.
Articolo pubblicato su L’Unità, 7 aprile
2003. www.unità.it
Piccone, M.
Allarme: la “pillola dell’obbedienza”
torna in farmacia. Articolo pubblicato su L’Unità, 27 settembre 2004. www.unità.it
Pirella, A. Salute mentale e poteri di mercato. Atti
del Convegno Internazionale Farmaci e Salute Mentale, Roma, 14 maggio 2004. www.psichiatriademocratica.com
Pirella, A. Stop exclusion-dare to care. Articolo
pubblicato su Liberazione, 8 aprile 2001. www.liberazione.it
Pirella, A. Verifica collettiva e trasmissione delle
esperienze. Atti del Convegno Nazionale di Psichiatria Democratica,
Vico-Equense (Na), 9-10-11 novembre 2000.
Dizionari ed Enciclopedie
Bleandonu, G. (1979). Dizionario di
psichiatria sociale. Roma: Editori Riuniti.
Devoto, G. & Oli, G. C. (2000). Il dizionario della lingua italiana.
Firenze: Le Monnier.
Galimberti, U. (1999). Enciclopedia di psicologia. Milano: Garzanti.
L’Universale. La grande enciclopedia
tematica. Enciclopedia generale. (2003).
Milano: Garzanti.
L’Universale. La grande enciclopedia
tematica. Filosofia. (2003). Milano:
Garzanti.
Laplanche, J. & Pontalis, J. B.
(1968). Enciclopedia della psicoanalisi.
Bari: Laterza.